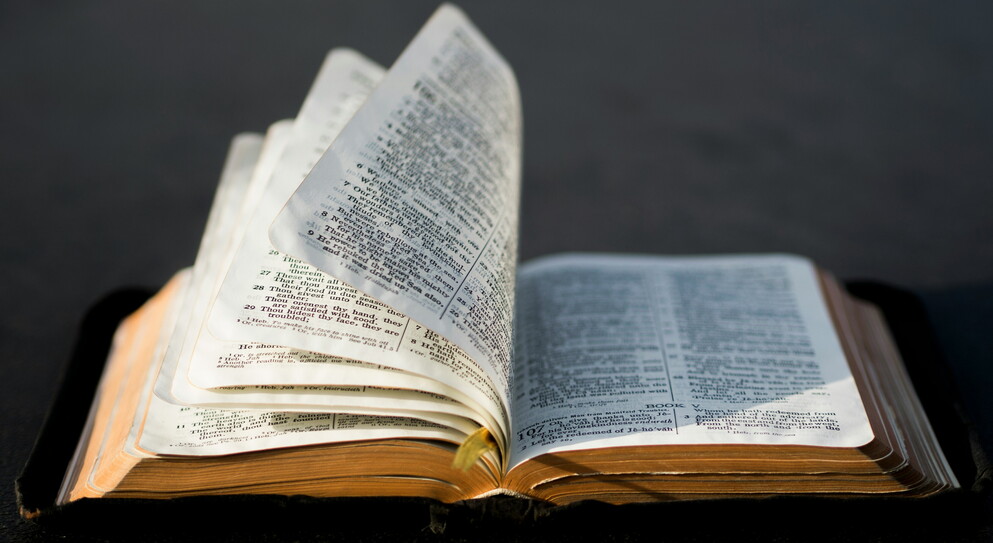Dio non ci salva per meriti nostri, anzi. Se si vuole rileggere Genesi e la Bibbia, da soli o guidati, il nuovo libro di Marilynne Robinson è un grande (e mai banale) aiuto
Quanti di noi, come il professore Bianco di Sunset Limited di Cormac McCarthy, interrogati sull’importanza della Bibbia, dovremmo ammettere che sì, certo, è un libro straordinario, forse il più influente mai scritto; ma che non lo abbiamo mai davvero letto? La grande scrittrice americana Marilynne Robinson ci viene in aiuto con il suo recente “Leggere Genesi”, portato in Italia da Marietti.
Da buona protestante, Robinson ha un sentimento intimo e personale della Bibbia, come sa chi abbia letto il suo romanzo Gilead, premio Pulitzer nel 2005. La lettura da lei proposta del primo, fondamentale libro della Bibbia è illuminante, e non adatta ai bigotti. La tesi di fondo che Robinson vuole dimostrare, infatti, è che Dio non ci salva per meriti nostri. Anzi! Che disastro questi Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe: tutti i patriarchi di cui ascoltiamo in chiesa fin da bambini con timore e tremore, a leggere per intero le loro vicissitudini si rivelano in buona sostanza dei poveracci e dei meschini, come lo saranno più tardi i discepoli di Gesù. Ingannano, sono cocciuti, tante sono le volte che ascoltano la voce di Dio quante quelle in cui se la dimenticano. Non è per propria bravura che quello di Israele è il popolo eletto: spesso anzi nella Bibbia i pagani fanno figure ben migliori.
Ma Genesi “non è primariamente inteso a offrire esempi di virtù o di eroismo […], mira invece a tratteggiare l’operato di Dio nei confronti dell’umanità attraverso la disgrazia, il fallimento e persino il crimine.” Infatti, “nonostante e attraverso lo scompiglio umano sta accadendo altro”: il piano della salvezza, una storia scritta dritta su righe molto storte, quelle della “vita di persone per molti aspetti così ordinarie che è sorprendente trovarle in un testo antico”. Con questi zotici pastori del Medio oriente siamo lontani anni luce da Gilgamesh o dagli eroi omerici; eppure “questi uomini e queste donne hanno visto il volto di Dio, hanno udito la Sua voce”. Grazie a ciò hanno compiuto scoperte meravigliose e decisive, inaudite in tutta la cultura classica.
Per esempio, pur circondati da popoli che venerano divinità mostruose, i patriarchi intuiscono che Dio è un padre amorevole (e il problema del rapporto tra padri e figli è quello cruciale in tutto Genesi); che il mondo “è atto al godimento umano”, tanto che con eleganza Genesi nota prima la bellezza degli alberi, e solo dopo che rendano frutti; e soprattutto che il perdono “in ogni occasione in cui nasce, è ricompensato da conseguenze che non potevano essere previste né immaginate”. Tanto che, fa notare Robinson, l’intero Genesi è “incorniciato da due storie di perdono straordinario, quello di Caino da parte del Signore e quella dei dieci fratelli da parte di Giuseppe”.
Che ne sarebbe stato della storia del mondo senza le intuizioni stra-ordinarie di quei pastori erranti della Mesopotamia? Dunque, ben venga rileggere Genesi e la Bibbia, da soli o guidati. Quello di Robinson è un grande (e mai banale) aiuto.