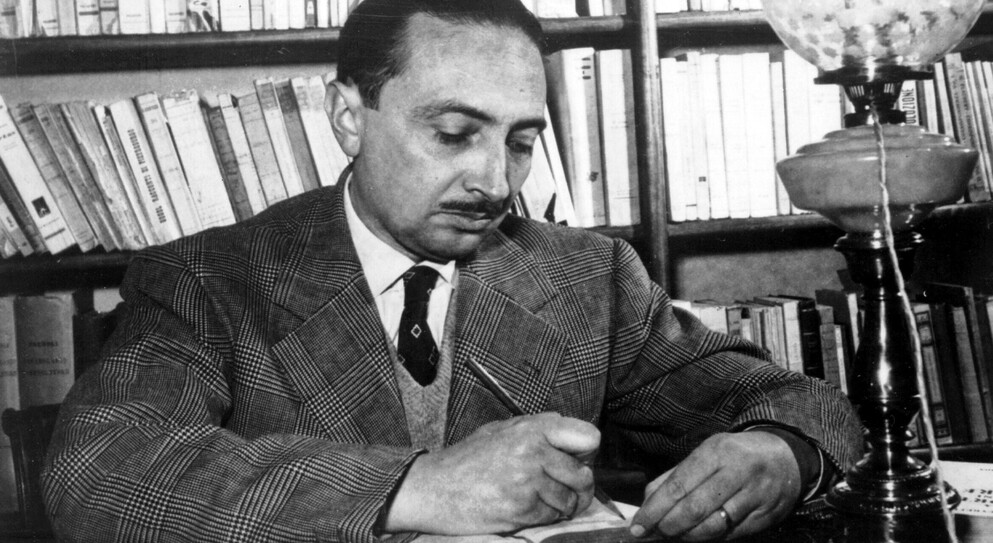Ancora a discutere di egemonia culturale, di destra e di sinistra. Come se non fosse esistito il ’900 degli irregolari. Chi votava, Montale? E Gadda, Buzzati, Ortese? Custodivano la loro zona franca, liberi dal conformismo rosso o nero
Basta, per favore, basta. E’ un grido di dolore. Una supplica. Un lamento disperato. Basta. Basta con le baruffe ammuffite sull’“egemonia culturale” esercitata – amata, odiata, detestata, rimpianta – della sinistra, nostalgica, e su quella subìta dalla destra, rancorosa. Basta con questa rappresentazione puerile del mondo della cultura come se fosse una guerra interminabile tra soldatini: le giubbe rosse di là, quelle nere di qua. Basta con le recriminazioni, i proclami, le trincee di una guerra finta, oramai caricaturale: quella vera, del resto, è finita da tempo.
La gabbia di uno zoo fallito. Una “bolla”, come si dice adesso, vuota e separata, da piccolo e sparuto gruppo inascoltato. Che non tiene conto della storia, della cultura di questo dopoguerra, e che proietta sull’oggi, come se fossero tizzoni incandescenti, le ombre di un passato peraltro ritoccato, riaggiustato, falso. Perché in quello vero vanno ricordate le stelle di chi, in solitudine, rifiutò la militarizzazione della cultura, la chiamata alle armi, l’irregimentazione conformista. La comunità degli inclassificabili, dei renitenti alla leva. Degli irregolari. Di quelli che hanno scritto, dipinto, suonato, disegnato, scolpito, progettato, diretto film e rappresentazioni teatrali avendo come scopo non la fedeltà a una linea o a uno schieramento, ma la riuscita artistica di un film, di un romanzo, persino di un articolo. Ce n’erano, eccome. E anche di qualità sublime.
Eugenio Montale. Chi votava, Montale? In quale esercito culturale si era arruolato? Nella sinistra o nella destra? Mentre negli egemonici di sinistra si intimava di andare “verso il popolo” (il populismo non l’hanno inventato i brutti e cattivi di oggi, come del resto aveva scritto in “Scrittori e popolo” Alberto Asor Rosa, comunista militante ma, almeno nei suoi tempestosi inizi, “irregolare”), Montale rivendicava addirittura il deliberato rinchiudersi nella sua “torre d’avorio”, recalcitrava di fronte “al vaniloquio delle tendenze” (tutt’e due. Indistintamente), animato da una sola missione: comporre le magnifiche poesie che conosciamo.
Montale rivendicava addirittura il deliberato rinchiudersi nella sua “torre d’avorio”, recalcitrava di fronte “al vaniloquio delle tendenze”, animato da una sola missione: comporre le magnifiche poesie che conosciamo
Missione compiuta. Le “tendenze” del vaniloquio sconfitte. E Federico Fellini? In quale casella vogliamo imprigionarlo? Nulla, della sua estetica, sembra conformarsi a un principio di disciplina politica, egemonica o anti egemonica. Appena uscita “La dolce vita”, il mondo conservatore e cattolico reagì con scandalo, e non tardò ad arrivare la scomunica dell’Osservatore Romano sotto forma di un articolo intitolato “La sconcia vita”, il cui autore peraltro pare fosse Oscar Luigi Scalfaro in persona. Tempo qualche anno, la fine dei Settanta, e la sua “Prova d’orchestra” fu giudicata a sinistra non come un apologo, ma come un’apologia dell’uomo forte, della soluzione autoritaria, dell’ordine minacciato e ristabilito. E Fellini fu quasi anatemizzato. Guido Piovene, il “conte rosso”, come lo chiamavano i suoi nemici di destra, passò gli ultimi anni a realizzare, assieme a Indro Montanelli ed Enzo Bettiza, le eccellenti pagine culturali del montanelliano Giornale nuovo: che strano, deve aver violato la disciplina militare delle egemonie.
In un piccolo volume delle Edizioni Liberal che Nicoletta Tiliacos e Ferdinando Adornato mi incaricarono di curare e che si intitolava “Gli irregolari” (ognuno ha le sue ossessioni), Raffaele La Capria ha citato un passaggio del racconto “Antipatici” tratto dai “Sillabari” di Goffredo Parise. In questo racconto Parise si immaginava sgradevolmente pressato da un amico egemonico con la fissazione dell’engagement (Pasolini, si vociferò) per partecipare, testuale, al “processo di rivoluzionarizzazione”. Laconica e sprezzante la risposta di Parise: “Può darsi, non me ne intendo”. Rivendicava il suo essere “un po’ pigro che non si era mai interessato di politica perché non riteneva affatto, nonostante i rimproveri che gli piovevano da tutte le parti, che ogni azione umana è un’azione politica”. Uno dei migliori scrittori del dopoguerra era perciò di destra? Era di sinistra? O semplicemente non era arruolabile, facendo a pezzi le intimazioni delle egemonie contrapposte che ancora oggi battibeccano sul nulla? E lo stesso Dudù La Capria, quale etichetta si sarebbe meritato? “Ferito a morte”, il suo capolavoro, a quale categoria egemonica apparteneva? E’ Elisabetta Rasy che nel suo “Perduto è questo mare”, edito da Rizzoli, descrive piuttosto la grazia malinconica, garbata, colta con cui La Capria si ritraeva dai conformismi, dalle “linee”, dal chiacchiericcio iper politicizzato.
E di Dino Buzzati si conoscono forse proclami, appelli, indignazioni, dichiarazioni, stentoree prese di posizione, tessere, mostrine, uniformi? No, non se ne conoscono, lui non aveva indossato nessuna divisa. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per i suoi detrattori, era un reazionario a prescindere. Aveva passato tutta la vita non a occuparsi di politica, bensì a leggere in solitudine e poi a comporre il suo capolavoro, “Il Gattopardo”, che purtroppo non avrà in sorte di vedere pubblicato dopo la lunga trafila dei “non si stampi” delle case editrici egemoniche (il “si stampi” venne da un editore con molte tentazioni culturalmente irregolari come Feltrinelli). Nicola Chiaromonte era talmente irregolare, esule antifascista, combattente della guerra di Spagna insieme a Malraux, antitotalitario e anticomunista negli anni dopo la guerra, critico teatrale prestigioso, fondatore con Ignazio Silone e Gustaw Herling di una delle più belle riviste dell’Italia repubblicana come Tempo Presente costretta a chiudere nei dintorni del ‘68, da morire in assoluta solitudine a causa di un infarto in un ascensore della Rai dove si era recato per racimolare qualche collaborazione, oramai isolato, trattato come un appestato e praticamente senza lavoro.
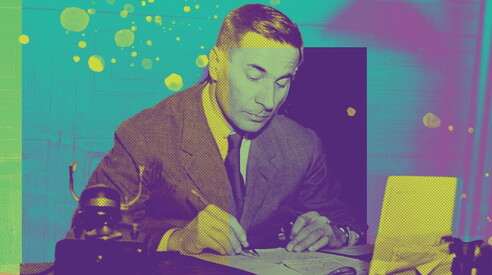
Gli orfani della sempre più stanca disputa sulle egemonie culturali, impegnati nel ring per compiacere le curve, non saprebbero come incasellare Vitaliano Brancati, che era caduto da giovane nella seduzione del fascismo, ma decise nel dopoguerra di non replicare l’errore arruolandosi nel campo opposto, come invece avevano fatto spudoratamente molti dei suoi simili e dei suoi coetanei, e di non essere più “ingaggiato” nelle milizie che si contendevano il controllo della “massa”: “le piazze che essa riempie”, scriveva Brancati nel suo “Diario romano”, un autentico manuale dell’intellettuale irregolare e anti egemonico, “ora in camicia nera, ora col basco, ora con la bustina di carta, ora col fazzoletto, sono il campo della storia, ed essa, con i suoi perpetui sì e con i suoi pugni tesi contro il nemico del momento, fa la storia. Una commedia, che osi non adulare questa massa, cade sotto i fulmini di tutti i retori d’Italia, della destra e della sinistra”. E cadde anche lui sotto i fulmini dei retori, visto che persino il suo “Ritorno alla censura”, una censura molto più sottile e asfissiante di quella che solitamente impera nei regimi, avrebbe fatto molta fatica prima di trovare un editore disposto a sfidare le ire dei nuovi intolleranti.
Ingabbiare in un’etichetta politica Carlo Emilio Gadda è praticamente impossibile. Il Gadda venerato, faro di ogni avanguardia, campione massimo della letteratura, non tollerava etichette, appartenenze, poetiche e manifesti di partito. La sua parentesi mussoliniana, fitta di elogi per il Duce del fascismo, fu riscattata da “Eros e Priapo”, uno dei più veementi e corrosivi attacchi alla figura, anche fisica, di Benito Mussolini. Ma dopo quel libro, come ha scritto Walter Pedullà, “erano bugie per Gadda il neorealismo, l’impegno politico della letteratura”, persino “la prosa troppo semplice” di chi prediligeva l’andata verso il popolo. Fu bollato come uno snob, ma Gadda, “l’Ingegnere in blu” che non era precisamente un cuor di leone, non arretrò nemmeno di un millimetro nella rivendicazione della sua irregolare e snobistica solitudine.
Ingabbiare in un’etichetta politica Carlo Emilio Gadda è praticamente impossibile. La sua parentesi mussoliniana fu riscattata da “Eros e Priapo”, uno dei più veementi e corrosivi attacchi alla figura, anche fisica, di Benito Mussolini
La ricostruzione odierna della cultura italiana post fascista come un duello cruento tra il rosso e il nero è invece fondata su due “invenzioni della tradizione”, come le avrebbe definite Eric J. Hobsbawm. Una dettata dalla spocchia di chi, ritenendosi a sinistra custode dei valori della cultura, dello spirito e della supremazia morale della “parte giusta”, boccia rozzamente come “incultura” qualunque incursione della destra nel magico mondo degli intellettuali. L’altra interiorizzata dalla destra come fonte permanente di risentimento, anche a decenni di distanza, quando sono almeno trent’anni, dai tempi dell’oramai archeologico “sdoganamento”, che la destra non è più il luogo dell’esclusione, della minoranza in trincea, della cultura sulfurea e vissuta. Una storia di polemiche che pure ha avuto una sua stagione di gloria, ma che oggi è vecchia, decrepita, senza ascolto. E’ come se non si fossero accorti del passaggio dalla lira all’euro: il loro mondo emotivo è ancorato alla lira, e fanno finta di credere che quel mondo non sia svanito. E infatti eccolo: l’eterno ritorno del sempre uguale (richiamo a Nietzsche: di destra o di sinistra?), l’eterna e stucchevole riproposizione di un dualismo antagonistico e irriducibile, e oramai auto-parodistico, tra “fascisti” e “comunisti” (senza virgolette sono stati la tragedia del Ventesimo secolo, con le virgolette sono la farsa del secolo che viviamo). Come se non ci fosse null’altro, come se il conflitto fondamentale fosse tra queste due entità metastoriche.
E’ come se non si fossero accorti del passaggio dalla lira all’euro: il loro mondo emotivo è ancorato alla lira, e fanno finta di credere che quel mondo non sia svanito
E infatti questa grottesca semplificazione nemmeno può sapere, e figuriamoci se può capire, il senso dei ventisette anni che ci sono voluti per tradurre e pubblicare in Italia, e con una casa editrice tutt’altro che mainstream, “La società aperta e i suoi nemici” di Karl Raimund Popper, le cui pagine oggi sono sbocconcellate con voluttà strumentale da chi alle sue spalle non può decisamente vantare un incontaminato pedigree liberale. O dei quindici anni trascorsi per la traduzione in Italia delle “Origini del totalitarismo” di Hannah Arendt. Per dire la complessità delle cose, specialmente in quelle della cultura. E per dire in quale angoletto buio sia stata relegata in Italia la cultura liberale, così variegata e multicolore.
Storie complesse come la figura di Anna Maria Ortese, che fu trattata con mezzi “radicalmente punitivi” per aver messo a soqquadro il mondo intellettuale partenopeo nel suo “Il mare non bagna Napoli”. La Ortese, ha scritto sempre Elisabetta Rasy, “non fu né una dissidente ideologica, né un’apostata. Finì semplicemente per essere, nel panorama culturale della sua giovinezza e maturità, un’impolitica, una figura che non aveva vera voce nel dibattito culturale e, infine, una figura del silenzio”. Considerata un’estranea, troppo inquieta nella sua irregolarità per essere irregimentata con successo. Né egemonica, né controegemonica. Come Ennio Flaiano, il principe assoluto degli irregolari, il primattore, come ha scritto Giampiero Mughini, di “quelli che non parteggiavano né per i preti né per i comunisti”, custode geloso di una zona franca dove, anziché al rosso o al nero, si doveva ironica e moderata devozione al “Blu di Prussia”.
E poi ci sarebbe Mario Soldati, uno scrittore libero e mercuriale, insieme, come ha scritto Raffaele Manica (curatore dello stupendo Meridiano Mondadori dedicato all’irregolare Nicola Chiaromonte), “italianissimo e controitaliano, cosmopolita e regionalistico, gesuitico e luterano, asseverativo e contraddittorio, naturale e artificioso, monogamo e dongiovannesco”. E poi ci sarebbero, alla rinfusa, irregolarmente, senza un ordine preciso, ma senza inchini alle egemonie della seconda metà del Novecento, nell’Italia repubblicana: Alberto Arbasino, Alberto Burri, Liliana Cavani, Lina Wertmüller, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, Roberto Longhi, Alda Merini, Renzo De Felice, Chiara Frugoni, Alberto Savinio nei suoi ultimi anni, Serena Vitale, Pupi Avati, Beppe Fenoglio, Cristina Campo, Giovanni Comisso, Fernanda Pivano, Tommaso Landolfi, il divino sodalizio Fruttero&Lucentini, Giovanni Macchia, Pietro Citati, Geno Pampaloni, Mario Bortolotto, Nicola Abbagnano, Maria Corti, Angelo Maria Ripellino, Oriana Fallaci e chissà quanti altri (Leonardo Sciascia?), senza etichette e divise. O ci sarebbe Pietro Germi, tenuto ai margini perché, figurarsi, minoritario socialdemocratico di tendenza saragattiana – socialdemocratico, come riformista del resto, era ancora una parola tabù – che per una ragione o per un’altra (o forse sempre la stessa, dettata dalla sua ostinata “inaffidabilità” politica) ad ogni capolavoro veniva attaccato. Impenitente e sospetto “moralista” per “Sedotta e abbandonata”, poco antimafioso nel “In nome della legge”, poco incline all’ottimismo del sol dell’avvenire in “Il cammino della speranza”. La speranza è che la solita lagna delle egemonie culturali abbia un termine. Ma c’è poca speranza.