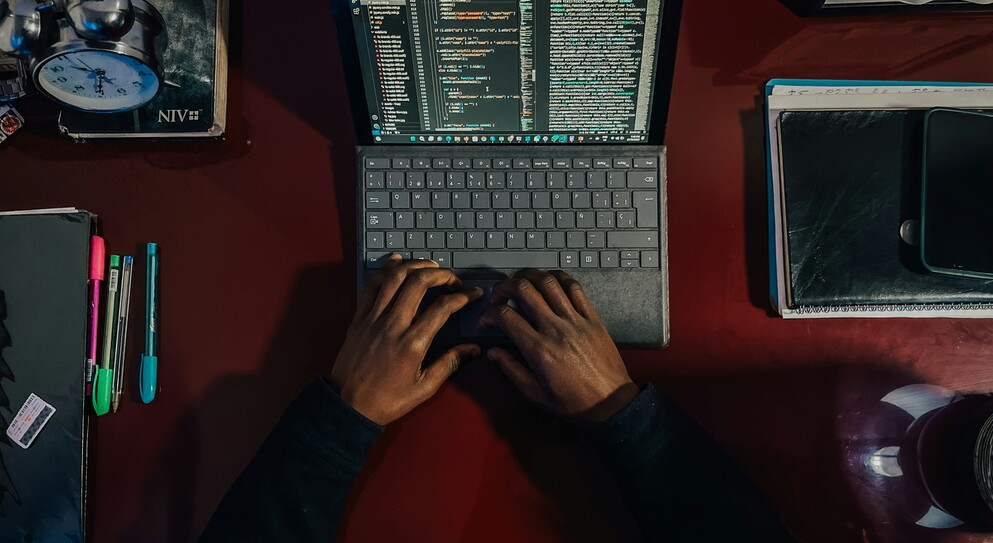Un saggio che ha una prospettiva realistica-ottimista riguardo al rapporto tra tecnica e sviluppo umano, senza cadere però in un’analisi teorico-filosofica. Si tratta di un’eccezione nel panorama italiano dove di solito troneggiano tronfi gli apocalittismi del progresso tecnico-economico-scientifico
È raro leggere un saggio che abbia una prospettiva realista-ottimista riguardo al rapporto tra tecnica e sviluppo umano. Raro in particolare in Italia, dove di solito troneggiano tronfi gli apocalittismi del progresso tecnico-economico-scientifico. Tale felice eccezione è “I confini dell’umano” (il Mulino) di Davide Sisto. Il testo di Sisto non propone tanto un’analisi teorica-filosofica, sebbene pure quella sia presente, della relazione tra uomo e tecnologia ma mostra il modo specifico in cui le tecniche entrano nella nostra vita, modificandola e quasi sempre migliorandola. Non mancano, annoia persino scriverlo, i lati negativi di tutto ciò, ma è talmente scontato che è fasullo e ideologico sottolinearlo. Basti pensare, a tal riguardo, alla sterminata, inesauribile e quasi incancellabile memoria dell’apparato digitale, che tende a conservare tutto con il rischio di ridurci all’Ireneo Funes di Borges che ricorda ogni minimo dettaglio senza essere in grado di concettualizzarlo, riserva colossale e informe di informazioni inutili. Ma Sisto non si fa sedurre dall’aspetto critico della relazione con la tecnica e racconta, tra i tanti esempi che riporta degli stupefacenti apparati tecnologici contemporanei, come anche questo colossale e inquietante magazzino della memoria possa essere distillato in progetti che aiutano le persone malate di demenza senile o di Alzheimer.
Il libro di Sisto si pone come un catalogo ragionato delle innovazioni che stravolgono la vita umana, talvolta inquietanti, certo, ma che non possono essere ignorati o scavalcati, bensì vanno vissuti e attraversati. E in tal modo, inevitabilmente, le innovazioni ci cambiano. Questo, allora, significa divenire esseri “ibridi”, naturali e artificiali? Ma questa domanda non ha senso, non ha mai avuto senso, l’uomo è per sua stessa costituzione un ibrido. La prospettiva di Sisto è chiarissima fin dall’inizio. Dobbiamo porci rispetto al progresso umano, e alla nostra storia fin qui, non come se lo sviluppo raggiunto sia un compimento, ma solo un punto d’arrivo che prelude a un ulteriore salto in avanti. L’idea di essere un corpo tecnicizzato non è un’anomalia, o qualcosa di cui dubitare, ma è la verità della relazione stessa tra l’uomo, la sua intelligenza, il mondo e le cose. Un mondo che l’uomo naturalmente rende progressivamente più simile a sé fino a creare una “seconda natura”, un mondo nel mondo che non è “altro” dal mondo reale, ma che rende il mondo sempre più simile al suo principale attore intelligente, sempre più adeguato alle sue esigenze in costante evoluzione. Certo possiamo gridare “fermiamo il mondo, voglio scendere”, sta nell’atto di libertà di ciascuno.
Ma pensare che non vi sia una sorta di stupefacente e inevitabile piano inclinato generato dallo stesso fare libero e creativo dell’uomo è non voler vedere le cose nella loro fattualità. Come recita la splendida citazione di una conferenza di H.G. Wells che apre il libro: “È possibile credere che tutto il passato non sia che l’inizio dell’inizio, e che tutto ciò che è e che è stato non siano che le prime luci dell’alba […] Tutto questo mondo è pieno di promesse di cose più grandi, e verrà il giorno, un giorno in una successione infinita di giorni, in cui gli esseri, esseri che sono latenti nei nostri pensieri e nascosti nelle nostre menti, si innalzeranno su questa terra come possiamo ergerci su uno sgabello, e ridendo tenderanno le loro mani verso le stelle”. Ed è una poderosa idea di futuro che fa il paio con quella praticamente coeva che sta alla fine del libro di Bergson “Le due fonti della morale e della religione”, secondo cui l’universo non sarebbe altro che “una macchina per produrre déi”. In questa promessa ultra-umana vi è in realtà il più profondo umanismo, ossia l’idea che l’uomo è la propria trascendenza, il proprio inoltrarsi costantemente oltre se stesso, la gioiosa scommessa della morte quotidiana, del terminare continuo della nostra vita, in ogni istante, per potere continuamente germogliare. Vi è il rifiuto della stasi, dell’identico e della ripetizione. Il rifiuto di un mondo che sia sterile e mortifera conservazione dell’esistente.