Il nuovo libro di Roberto Esposito mostra che per capire il fenomeno serve lo sguardo filosofico, capace di cogliere il continuo rovesciarsi di un elemento nel suo contrario senza smarrire il risultato d’insieme
C’è un motivo per cui la filosofia ha qualcosa da dire sul fascismo: è disciplina dialettica, amica delle contraddizioni e sovrapposizioni; nel buio scorge fosforescenze, nella luce ombre. Se la cava meglio con oggetti complessi e articolati che con blocchi di marmo. Il fascismo è uno di questi: un patchwork di destra e sinistra, socialismo e nazionalismo, reazione e sindacalismo rivoluzionario, futurismo e passatismo, tecnofilia e ruralismo, mitologia e cinismo. Il nuovo libro di Roberto Esposito, Il fascismo e noi. Un’interpretazione filosofica (Einaudi, 316 pp., 26 euro) mostra che per capire il fenomeno non bastano erudizione storiografica, economia, sociologia, psicologia: serve lo sguardo filosofico, capace di cogliere il continuo rovesciarsi di un elemento nel suo contrario senza smarrire il risultato d’insieme.
Le letture filosofiche del fascismo furono numerose e appassionanti già negli anni Trenta, soprattutto in Francia e da parte di intellettuali tutt’altro che fascisti: Lévinas, Bataille, Weil. Poi vennero quelle di Gentile in pubblico, e di Heidegger in segreto. Dopo, quasi nulla, con le eccezioni, ancora francesi, di Foucault e Deleuze. Una causa di questa povertà è il dominio della storiografia marxista, la cui canzone da organetto riduceva il fascismo a “cane da guardia” degli interessi borghesi. Oltre alla miopia economicistica ha pesato la oggettiva difficoltà di ricondurre il fascismo a un significato univoco – difficoltà che tanto eccita quanto scoraggia il filosofo, spinto in mare aperto dall’indole avventurosa e però desideroso di mettere piede sulla terra di una concettualità stabile e definita. La domanda decisiva, su cui Esposito insiste, è questa: il fascismo seppe giocare su più tavoli contemporaneamente, raccogliendo, sollecitando e mobilitando gli elementi più disparati della realtà – ma con quale scopo? Il “potenziamento della vita” della nazione, del popolo, della razza. Tale era innegabilmente la volontà fascista.
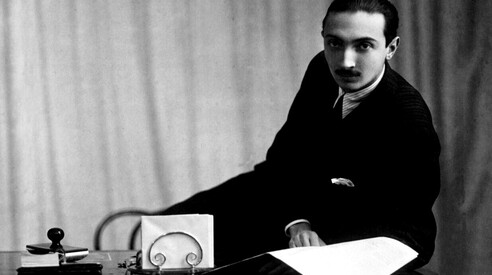
Come è innegabile il contrario, cioè che al fascismo (soprattutto tedesco) appartiene una fondamentale simpatia per la morte. Non solo – e non in primo luogo – quella altrui, ma anzitutto la propria: il fascismo ha incarnato uno spirito catastrofista e suicidario di intensità ed estensione inedite, di cui è prova bastevole l’ostinazione demente e lucida con cui la Germania condusse gli ultimi anni della guerra. Vita e morte: quale delle due fu messa al servizio dell’altra? Con una scrittura limpida quanto è radicale la sua ricerca, Esposito mette davanti al fascismo come un enigma di cui non è affatto detto ci si sia liberati. Se il fascismo è stato anche, come disse Thomas Mann, una caricatura della nostra cultura migliore, allora l’antidoto della filosofia non può essere il semplice anatema, ma il rischiaramento dell’enigma, che non sempre coincide con una soluzione. E’ più faticoso, ma certe volte, come questa, funziona.
