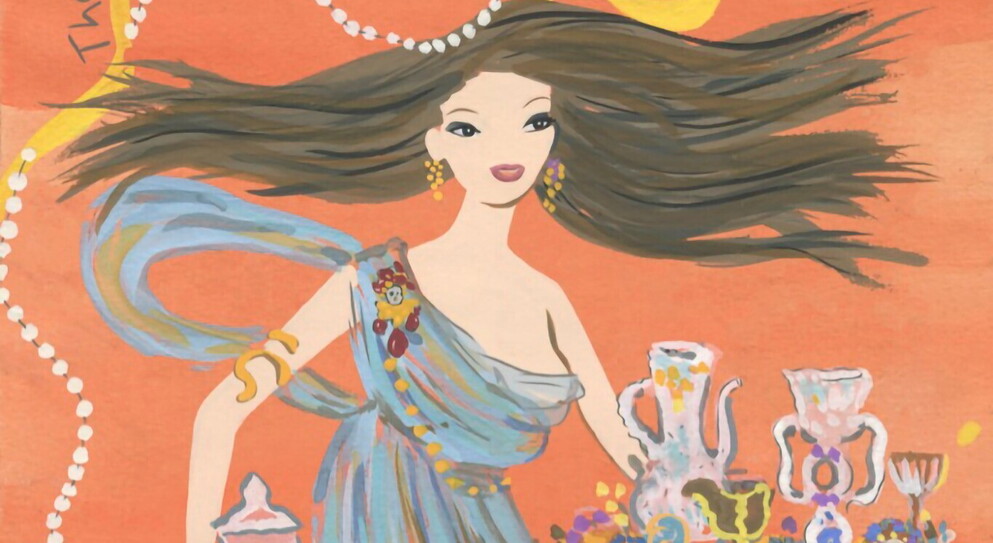Consigli (molto) richiesti di moda da parte di Diane von Fürstenberg, che si è trasferita a Venezia sia perché gli Stati Uniti di oggi non le piacciono granché sia perché considera la Laguna “la prima startup della storia: è sistema, prodotto, estetica, economia, politica, desiderio”
C’è qualcosa di irresistibilmente anacronistico in Diane von Fürstenberg, un senso del tempo che non si misura in stagioni di passerella, ma per epoche interiori; un’idea di stile che non cerca la ribalta, ma l’autorevolezza, un modo di concepire la moda che, pur muovendosi dentro il sistema, ne rifiuta l’automatismo e che, in tempi di slogan e capsule, di claim femministi stampati su cotone non equo e collezioni cruise che si trasformano in viaggi veri per chi vi assiste, continua a preferire l’azione alla dichiarazione. Lei non è soltanto una stilista né soltanto un’imprenditrice, ma una costruttrice. Di vestiti, certo – il suo wrap dress, creato nel 1974, è già leggenda – ma soprattutto di donne.
“Il mio obiettivo non era di vestirle, ma di valorizzarle e dare loro potere”, ha ripetuto negli anni, senza mai alzare la voce, senza mai arretrare. Se oggi, in un’epoca in cui persino il potere è diventato estetica, se la sua lezione continua a valere, è perché non si è mai fondata sulla superficie, ma nutrita di profondità. Nata Diane Halfin in Belgio, nel 1946, figlia di una sopravvissuta ad Auschwitz, DvF – come la chiama il suo ufficio stampa – ha imparato molto presto che ogni gesto – anche quello apparentemente frivolo del vestirsi – può essere un atto di affermazione. L’abito a portafoglio, che non ha bottoni né zip e si chiude da solo, è stato letto come simbolo di emancipazione femminile, ma lei, con l’intelligenza di chi rifugge ogni mitologia, ha sempre rifiutato le interpretazioni eroiche: “Volevo essere essere una donna in charge, lo sono diventata grazie a quel ‘vestitino’ e mi è successo per caso”, racconta al “Foglio della moda” in una limpida mattina di fine agosto, in un salone dell’ appartamento molto scenografico a Palazzo Giustinian Brandolini affacciato sul Canal Grande dove le piace organizzare, non spesso, cene a scopo sociale e culturale e dove pochi mesi fa ha accolto Jeff Bezos nella sua prima serata pre-matrimoniale in Laguna. “Ero a Cortina con Egon (von Fürstenberg, il suo primo marito, ndr) e mi presentò Angelo Ferretti, un visionario del tessile”. Quel ‘vestitino’, come lo chiama lei, fece sentire le donne più libere, non armate: più forti, senza essere dure. Belle, ma secondo un’idea di bellezza che non coincide con la giovinezza né con la seduzione. Insomma, “women in charge”, cioè in controllo ma anche potenti, con progetti da realizzare e rispetto da pretendere, che è anche il titolo del documentario biografico diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, uscito poco più di un anno fa, dove faceva a pezzi il mito vittimista americano di questo secolo e le eterne lagne sul metoo: “C’è sempre uno che vuole chiudersi con te in qualche stanza, è parte della vita, lo prendi a calci”, finita lì.
“La vera bellezza di una donna”, osserva oggi, “è per me lo sguardo, il sorriso e il linguaggio del corpo – precisa – a cui bisogna aggiungere l’indipendenza e il non avere paura, il non essere mai vittima, che sono poi stati gli insegnamenti di mia madre. La mia nascita – aggiunge – è stata un miracolo, perché lei era tornata da pochi mesi dai campi di concentramento e pesava ventinove chili. Il medico le disse che non avrebbe potuto avere figli e invece sono nata io”. Eccola, dunque, Diane, simbolo di un’industria che oggi tende a svuotare tutto ciò che tocca, nella quale lei ha mantenuto un’etica del senso, una sua particolare forma di resistenza: quella di non smettere mai di desiderare in un momento in cui la moda non accende più il desiderio, ma finisce con l’archiviarlo. Non lo provoca, ma lo distribuisce e il desiderio, si sa, ha bisogno di scarsità, di mistero e di una tensione che non si può scaricare in tre secondi con uno swipe. Come si fa, allora, a resuscitarlo? A questa domanda che sembra essere uscita da un seminario parigino del 1978, tra Roland Barthes e Diana Vreeland, DvF non risponde con una teoria, ma con una mossa e con una città, con una scelta. A settantotto anni, quando molti si ritirano in un’esistenza fatta di pranzi lenti e premi alla carriera, lei ha deciso di trasferirsi a Venezia. “Non per nostalgia, ma per necessità. Non per guardare indietro, ma per vedere meglio avanti, perché Venezia non è una città in cui ci si rifugia, ma una città che si affronta e si vive”, spiega. “La stessa in cui mi portò per la prima volta Egon quando avevo diciannove anni”, precisa lei che ha attraversato mezzo secolo di tendenze senza mai perdere la linea.

Dal 2001, è sposata con Barry Diller, magnate dei media, fondatore di IAC, sostenitore di arte e cultura, marito e complice, “una storia amorosa e intellettuale che sfida ogni schema”, come scrive lui nella sua autobiografia “Who knew”, uscita negli stessi giorni in cui, sul magazine “New York”, annunciava la sua omosessualità: “Ci sono stati molti uomini nella mia vita, ma solo una donna”, ha puntualizzato, aggiungendo di “non aver mai messo in dubbio che il nostro imperativo biologico fosse forte nella sua eterosessualità almeno quanto il suo opposto”. A New York, dove ha costruito il suo impero, e a Parigi, dove la moda si fa spettacolo, DvF ha preferito la laguna fragile e generosa, la città che non esiste senza la sua storia e che sopravvive perché è troppo bella per essere dimenticata. Quando dice, e scrive nel suo ultimo libro “Solution & Seduction”, edito da Marsilio Arte, che Venezia è “la prima startup della storia”, si potrebbe pensare a una boutade; invece la sua è una dichiarazione precisa. “Venezia”, spiega,” è sistema, prodotto, estetica, economia, politica, desiderio, proprio come la moda, ma con una differenza: sa che senza un’identità profonda, tutto crolla. Non ho mai avuto mentori, ma è lei la donna che avrei voluto essere”. Non certo una donna da copertina patinata, ma una figura in bilico tra il sacro e il secolare, come certe regine medievali raffigurate negli affreschi di Pisanello: bellissime, ma armate, eteree, ma determinanti. Diane l’ha presa in parola e ha creato per la 19esima Mostra Internazionale di Architettura, in programma fino al 23 novembre prossimo, la sua installazione visiva chiamandola come il libro e viceversa. Non un’iperbole, ma un’immagine forte e immaginifica, un omaggio alla città come archetipo femminile: forte, astuta, resiliente, capace di affascinare e durare.
Otto bandiere, ideate insieme con l’artista Konstantin Kakanias, germogliano lungo il viale dei Giardini della Biennale: Architetta, Ingegnera Marittima, Mercante, Finanziera, Musa, Diplomatica, Giudice, Madre della Repubblica, otto incarnazioni che stanno sul confine tra storia e simbolo. Venezia diventa così non solo luogo, ma contenuto e Diane, nel restituirla al mondo attraverso nuovi volti, ci mostra così che “la moda può ancora essere racconto, proposta e cittadinanza”. Qui il desiderio non smette mai di (soprav)vivere. “Sono una vecchia signora, ne ho viste di tutti i colori, lo dico senza vantarmi, ci mancherebbe. Non sono per niente blasé, disincantata. Non esserlo è più che mai necessario”. Precisa: “Far resuscitare oggi il desiderio nel mondo della moda è difficile, perché è cambiata completamente ed è tutto marketing. In un periodo come quello che stiamo vivendo, poi, di mediocrità e avidità continua, la situazione è ancora più terribile, non soltanto in quel campo. Non ho mai vissuto un momento come questo, si parla solo di soldi e stiamo dimenticando quali sono i veri valori e ciò che conta davvero, a cominciare dal rispetto dell’ambiente, come ci ha ricordato qualche sera fa Fany Kuiru Castro, coordinatrice generale di COICA e sostenitrice dei diritti indigeni e ambientali, durante la cerimonia della sedicesima edizione dei premi”. I “premi” sono i Diane von Fürstenberg Awards, da lei pensati e voluti dal 2010, assegnati ogni anno a cinque donne per “il loro coraggio, la loro resistenza e la capacità di ispirarne altre, spesso in territori in cui il mondo non ha nessuna intenzione di farsi cambiare”.
Oltre a Castro, nel 2025 sono state premiate Christy Turlington Burns, ex top model, oggi attivista per la salute materna nel mondo con la fondazione “Every Mother Counts”, Hanin Ahmed, coordinatrice umanitaria in Sudan, Giulia Minoli, filosofa e presidente di “Una Nessuna Centomila” e Kim Kardashian, premiata per il suo impegno concreto nella riforma della giustizia penale negli Stati Uniti, di cui nessuno di noi parla mai, impegnati come siamo a decrittarne la variazione di forma e gli abiti che indossa. Premi che sono una liturgia sobria del coraggio femminile, una dichiarazione che la moda può ancora servire a qualcosa se smette di parlare solo di sé. E a proposito di moda, quali sono oggi le facce riconoscibili, tolto un maestro come Giorgio Armani? Le chiediamo. “Penso a Marc Jacobs, mio caro amico, che è venuto qui a Venezia con Sofia Coppola che gli ha dedicato un documentario, ma soprattutto a John Galliano, lo stilista più talentuoso di tutti. Per me è speciale, è uno che fa magie, soprattutto per la donna, proprio come ha fatto Yves Saint Laurent (a cui è dedicata fino al 5 ottobre una grande mostra a LUMA, ad Arles, ndr) che era incredibile!”. “Avere idee continue e realizzarle è un gran talento”, aggiunge, “ma non bisogna mai pentirsi. Io l’ho fatto solo una volta, perché non mi sono accorta subito di un problema che riguardava mia figlia. La cosa di cui vado più fiera? Non aver mai detto bugie. Amo la vita, sono una donna che ama la vita, la natura. Sono la donna che avrei voluto essere”, conclude, citando la sua autobiografia. Una frase che non è un claim, ma un’eredità, un invito a restare, a resistere e a continuare ad ascoltare, ad aiutare, come fa lei. E Venezia, e non solo, risponde.