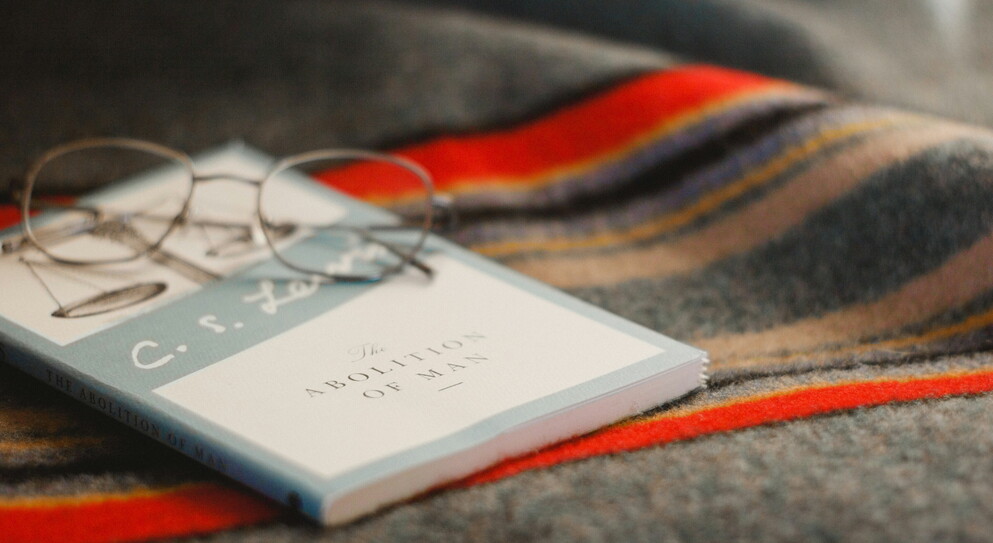La narrativa contemporanea sembra aver smarrito la distanza tra vissuto e visione, trasformando il dolore in materia prima indistinta. Quando il romanzo non apre prospettive ma si richiude sul sintomo, resta solo il referto mascherato da letteratura
Località adriatica. Sera, ore nove. Brezza impagabilmente piacevole. Lui e lei, sui quaranta. Camminano lungo un viale affollato del centro città. Odore di cocco, di forno a legna e di cuoio. In sottofondo, musichette dai negozi. Poi una voce che parla in un microfono. Non si distinguono le parole, portate a folate dal venticello, si sente solo che qualcuno – una donna – sta parlando. Lui dice a lei: “Ah, è cominciata la presentazione del romanzo di…” (cognome non notissimo). Lei risponde a lui: “Ommadonna, e chi è? Un’altra che ci racconta i suoi problemi?”. L’articolo potrebbe finire qui, sintesi vince su analisi. Ma corre l’obbligo – e noi gli scodinzoliamo volentieri dietro – di dare un seguito a quest’osservazione estemporanea, brutale come tutte le estemporaneità e non priva di verità come tutte le brutalità.
Che la narrativa contemporanea abbia preso la piega lirico-patologica appare sempre più innegabile. Si scrive in pianto, accasciati sulla propria cartella clinica. Chi non ce l’ha, se la si inventa – il che è apprezzabile e forse, ormai, perfino lodevole, per lo meno segno di una certa residuale vitalità. Non che sia la prima volta che accade, si controargomenterà: Giuseppe Berto ci narrava il male oscuro e Thomas Mann osservava un mazzuolin di internati in un sanatorio di Davos. Ma le affinità muoiono sulla buccia: Berto raccontava un sé che si trasforma in un io molteplice, refrattario, sfuggente, condannato, che risente di un’epoca, di una cultura familiare e nazionale e di una gamma di pretese che gli vengono imposte a cuor tragicamente leggero, e di tutto questo, quell’io che scola via si fa banco di prova dolorosissimo, diventando, di pagina in pagina, un colossale enigma frastagliato e illeggibile, di cui è difficile venire a capo salvo contentarsi della sentenza di morte che porta con sé. Thomas Mann andava in montagna non per ascendere a subilimi verità attraverso una Natura Amica fattasi Metafora all’uopo, ma per celebrare il funerale a un’epoca e alle sue illusioni, tratteggiando una tragedia mondiale e scovando il senso della malattia rappresentata come stato dell’anima, come status esistenziale e come destino – quella mano vista da Hans Castorp nella lastra, quello “sguardo gettato sulla propria tomba”, ah, memorabile…
Insomma, la malattia, in questi romanzi, è stata sempre e solo un sintomo di altro, un piccolo indizio per raccontare il resto, una lente che sfoca il centro per far vedere meglio i contorni. E forse è proprio questa la più corposa differenza che c’è tra un referto romanticizzato e la Letteratura: la Letteratura usa quel che usa per guardarci attraverso e per gettare uno sguardo fuori, su un abisso cui sente (scopre!) di appartenere (che Grande Malato è, in fondo, anche Gregor Samsa?); il referto romanticizzato guarda dentro e non ha ambizioni di prospettiva. Il referto romanticizzato è però spesso proposto nella forma illusoriamente universale (“tutti possono riconoscersi nel dolore della malattia”), quando in realtà nessuno che legga davvero legge per riconoscersi in un romanzo, semmai per dissolversi nel sé di un altro, dell’Altro per eccellenza, dunque per riconoscere un’estraneità che incontra e invoca la propria. Due lacrimatoi che confinano, invece, non significano niente, sebbene promettano di reggere il mercato editoriale. Parola chiave: prospettiva, come sempre. Se c’è, siamo in presenza di Letteratura. Il resto è allagare di lacrime la fossetta di un ombelico.