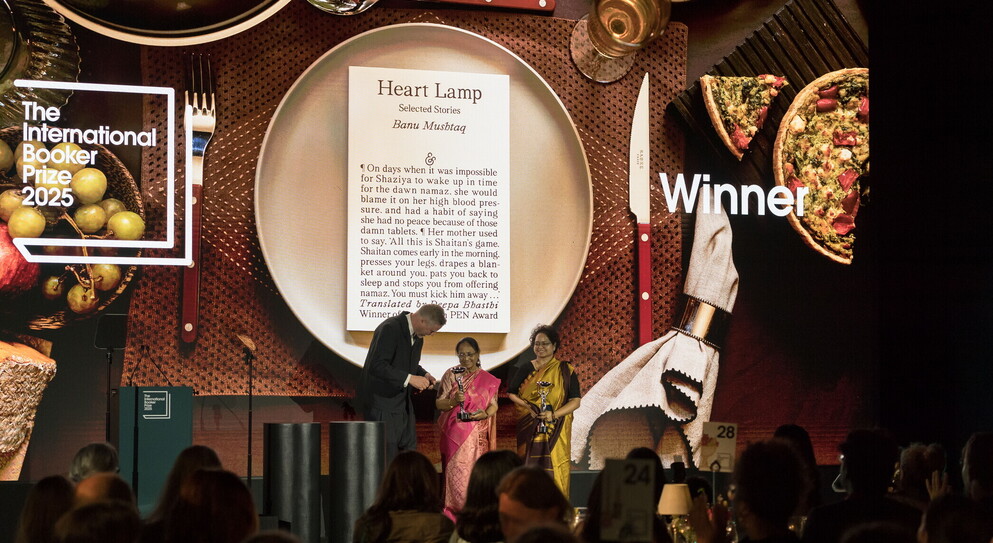I tredici autori selezionati provengono da nove nazionalità diverse, segno incontrovertibile di progresso e inclusività. Il Booker Prize 2025 quindi parla tante lingue, ma scrive in una sola: la grande letteratura inglese
La longlist del Booker Prize 2025 è stata salutata come la più globale della storia del premio, fondato nel 1969 ma esteso ad autori non britannici solo a partire dal 2014. I tredici autori selezionati – fra i quali spicca Kiran Desai, figlia di Anita e vincitrice del Booker già nel 2006 con Eredi della sconfitta (Adelphi, 391 pp., 19 euro) – provengono da nove nazionalità diverse, con Albania, Canada, Ungheria, India, Malesia, Trinidad & Tobago e Ucraina che si aggiungono ai più scontati Regno Unito e Usa. La circostanza è stata salutata come segno incontrovertibile di progresso, e lo è, a patto però di tenere presenti altri due fattori. Il primo è che a concorrere non sono gli autori bensì i libri, composti da parole e dalle immagini che evocano. Se queste immagini ci conducono nelle fattorie malesi o nel Giappone postcoloniale, fra i profughi kosovari o i centri adozione del Venezuela, resta quale comun denominatore la scelta della lingua inglese, che i più corrivi potrebbero interpretare come sintomo di colonizzazione culturale (perché non scrivere in ungherese, in ucraino, in albanese?).
Il secondo è che l’inclusività del Booker travalica nazionalità e genere (sette selezionate su tredici, tre giurate su cinque): il colosso Penguin Random House ha cinque selezionati, ciascuno con un marchio diverso, ma la casa indipendente Faber, da sola, ne ha tre; i selezionati spaziano da due esordienti (Ledia Xhoga e Maria Reva sono al primo romanzo; un esordiente non vince dal 2020) a un habitué come Tash Aw, alla terza longlist; fra i concorrenti ci sono vecchi bucanieri dell’editoria ma anche ex giocatori di basket e suonatori di mandolino (Ben Markovits e Andrew Miller); mentre nella ristretta giuria presieduta da Roddy Doyle spicca Sarah Jessica Parker. Non si tratta di mere note di costume. A tenere insieme questa molteplicità è la lingua, ossia la comune esperienza di avere letto e amato la tradizione letteraria anglofona, dalle origini ai giorni nostri, indipendentemente da provenienza e identità, nazionalità e mestiere. In fondo è per questo che il Booker viene quasi sempre vinto da un capolavoro: parte dall’assunto che, per scrivere bene, si debba leggere bene.