Gli editori commerciali non producono conoscenza; ne gestiscono semplicemente il confezionamento e la reputazione, traendo profitti altissimi da un servizio che, nella sostanza, viene prestato dal sistema pubblico senza compenso. Occorre intervenire direttamente sull’architettura economica che sostiene il settore
Il sistema attuale della pubblicazione scientifica si regge su una contraddizione che, a forza di essere ignorata, è diventata strutturale. La ricerca scientifica è finanziata quasi interamente con fondi pubblici, ma il controllo e la distribuzione dei risultati sono appaltati a soggetti commerciali che perseguono logiche di profitto, non di servizio pubblico.
Questo paradosso si alimenta su tre canali distinti di finanziamento occulto. Primo: i costi di pubblicazione, le cosiddette Apc (Article Processing Charges), che le istituzioni pubbliche pagano per permettere ai loro ricercatori di pubblicare articoli open access o a pagamento. Secondo: i costi di abbonamento alle riviste, che università, enti di ricerca e biblioteche continuano a sostenere, anche per accedere a contenuti che i loro stessi ricercatori hanno prodotto. Terzo: il lavoro gratuito svolto da referees e membri dei comitati editoriali, senza il quale il sistema non esisterebbe, e che viene fornito in larga parte da dipendenti del sistema pubblico.
In pratica, il sistema della pubblicazione scientifica moderna è finanziato interamente dal denaro pubblico: per generare i contenuti, per certificarli, per diffonderli, e infine per riacquistarli. Gli editori commerciali non producono conoscenza; ne gestiscono semplicemente il confezionamento e la reputazione, traendo profitti altissimi da un servizio che, nella sostanza, viene prestato dal sistema pubblico senza compenso.
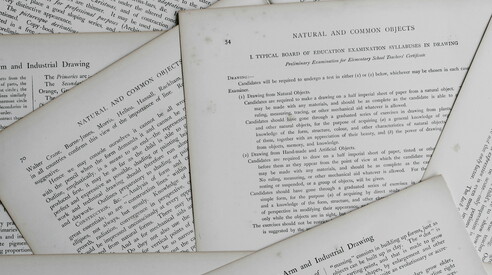
Questa situazione non è solo inefficiente. È il motore di distorsioni profonde e pervasive, che alterano la natura stessa della comunicazione scientifica. Il primo effetto è la proliferazione di riviste che rispondono non a un’esigenza scientifica, ma a una domanda di mercato. Gli editori, per massimizzare i profitti, moltiplicano i titoli disponibili, segmentano artificialmente le discipline, creano nuove testate per intercettare nicchie sempre più ristrette. Questo processo gonfia il volume complessivo delle pubblicazioni senza aumentare la qualità media, e al contrario contribuisce alla diluizione della rilevanza scientifica e alla frammentazione del sapere.
Parallelamente, la pressione sul numero di pubblicazioni come metrica di successo ha reso vulnerabile l’intero sistema alla crescita delle riviste predatorie: testate che simulano un processo di peer review, che accettano qualsiasi articolo in cambio di un pagamento, e che prosperano proprio perché il sistema esistente premia la quantità e non la qualità. Queste riviste non solo degradano il valore simbolico della pubblicazione scientifica, ma immettono nel circuito globale una quantità crescente di contenuti non verificati, confondendo i confini tra scienza affidabile e pseudo-scienza.
Un’altra distorsione è rappresentata dagli snatchers: soggetti che acquisiscono riviste rispettabili, spesso di nicchia o di ambiti specialistici, per poi svuotarle dall’interno, mantenendo una parvenza di autorevolezza formale mentre abbassano drasticamente gli standard di revisione per massimizzare il numero di articoli pubblicati e quindi i ricavi. Questo fenomeno mina direttamente la fiducia nella qualità delle pubblicazioni e rende sempre più difficile per i ricercatori, e per il pubblico, distinguere tra canali di informazione scientifica genuina e canali ormai degradati.
A monte di tutto, l’intera struttura del mercato editoriale incoraggia una logica perversa: non quella della selezione del miglior contenuto, ma quella dell’ottimizzazione del flusso economico. L’impact factor, che dovrebbe essere una misura imperfetta della rilevanza scientifica, diventa un asset commerciale da difendere o manipolare; la visibilità e la velocità di pubblicazione diventano criteri di scelta prioritari, indipendentemente dal rigore metodologico. In questo quadro, persino le pratiche di peer review rischiano di essere piegate a esigenze di rapidità, produttività, appetibilità di mercato, invece che alla valutazione severa e disinteressata della qualità della ricerca.

Il risultato complessivo è una comunicazione scientifica che, pur avendo aumentato enormemente la sua quantità e la sua accessibilità apparente, ha visto erodersi la sua funzione primaria: quella di certificare, selezionare e diffondere conoscenza solida. La frammentazione delle sedi editoriali, l’inflazione delle pubblicazioni, la crescente opacità dei criteri di qualità, la sovrapposizione di circuiti predatori e di facciata contribuiscono a indebolire l’autorevolezza della scienza stessa come impresa collettiva di conoscenza critica.
Di fronte a questa situazione, la proposta è di intervenire direttamente sull’architettura economica che la sostiene. L’idea consiste nel dirottare l’intero budget oggi destinato al mantenimento del sistema editoriale commerciale – comprendendo i costi di pubblicazione, quelli di abbonamento e il valore del lavoro gratuito di peer review – verso la creazione di un sistema di riviste scientifiche di proprietà pubblica, gestite da società scientifiche, accademie ed enti di ricerca. Esempi di riviste di prestigio già gestite da accademie scientifiche dimostrano la piena praticabilità di questo modello: il Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ad esempio, è pubblicato direttamente dalla National Academy of Sciences degli Stati Uniti e rappresenta una delle sedi più autorevoli della comunicazione scientifica internazionale.
Questa operazione, a differenza di quanto si potrebbe temere, non comporterebbe un aumento dei costi complessivi. Al contrario, vi sono buone ragioni per ritenere che si otterrebbe un risparmio significativo. La razionalizzazione del panorama editoriale permetterebbe di ridurre drasticamente il numero delle riviste attive, eliminando la proliferazione artificiale creata dalla logica commerciale. Il sistema avrebbe bisogno di molte meno riviste, meglio curate e più selettive, rispetto al panorama inflazionato attuale. Inoltre, i costi di mantenimento delle infrastrutture digitali – piattaforme editoriali, archiviazione dei dati, gestione dei processi di peer review – sono oggi largamente inferiori alle somme che vengono pagate agli editori commerciali, che realizzano margini di profitto annui superiori a quelli delle principali multinazionali tecnologiche. Le spese effettive necessarie per un sistema editoriale pubblico di qualità sarebbero una frazione di quelle attuali, rendendo l’operazione pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario. Un vantaggio ulteriore sarebbe l’abbattimento diretto dei costi di pubblicazione per i ricercatori, in particolare per quelli provenienti da paesi economicamente svantaggiati, che oggi si trovano esclusi sia dalla possibilità di pubblicare sulle migliori riviste sia dall’accesso completo alla letteratura scientifica. In un sistema pubblico open access, la possibilità di pubblicare e di leggere diverrebbe una funzione della qualità scientifica, non della disponibilità economica.
Il vantaggio fondamentale sarebbe l’eliminazione delle distorsioni di mercato descritte in apertura. Senza l’incentivo economico alla moltiplicazione delle riviste, verrebbe meno la spinta alla frammentazione disciplinare e all’inflazione delle pubblicazioni. Senza il modello commerciale che premia la quantità a scapito della qualità, le riviste predatorie perderebbero il loro terreno di coltura naturale. Senza la possibilità di monetizzare la reputazione delle testate attraverso operazioni di snatching, il mercato stesso delle riviste diventerebbe irrilevante. Il sistema tornerebbe a essere costruito intorno alla selezione rigorosa della conoscenza, alla responsabilità della certificazione, alla trasparenza dei processi di valutazione.
Naturalmente, esistono anche svantaggi e rischi. L’avvio di un nuovo sistema editoriale richiederebbe investimenti iniziali non trascurabili per l’infrastruttura tecnologica, per la formazione degli operatori editoriali e per l’organizzazione delle nuove piattaforme. Vi sarebbe il rischio di inefficienze iniziali, dovute alla mancanza di esperienza gestionale diretta da parte delle società scientifiche, abituate finora a delegare il processo agli editori commerciali. Sarebbe necessaria una forte standardizzazione dei processi editoriali per evitare la frammentazione tecnica e organizzativa tra le diverse riviste. Sul piano culturale, la resistenza alla pubblicazione in sedi nuove e non consolidate penalizzerebbe inizialmente l’attrattività delle nuove riviste, soprattutto nei settori più competitivi. Permarrebbe inoltre il rischio che la gestione editoriale venga catturata da gruppi di interesse disciplinari o nazionali, che potrebbero abbassare gli standard di selezione per favorire la propria cerchia o il proprio ambito.
Questi rischi, pur concreti, appaiono affrontabili con misure adeguate. Una governance chiara, composta da comitati editoriali eletti su base meritocratica e verificabile, e rotazione obbligatoria dei ruoli per prevenire la formazione di rendite di posizione, ridurrebbe il rischio di cattura. L’introduzione di audit periodici di qualità, gestiti da organismi indipendenti rispetto ai singoli enti editori, permetterebbe di monitorare e correggere tempestivamente eventuali derive. Una politica di accreditamento e valutazione delle riviste basata su criteri espliciti di qualità metodologica, apertura dei dati, trasparenza dei peer review, sostituirebbe progressivamente il prestigio di marca con la reputazione guadagnata sul campo. Infine, una strategia internazionale di cooperazione tra società scientifiche diverse permetterebbe di evitare la provincializzazione del sistema e di mantenere uno standard competitivo globale.
Le obiezioni prevedibili a questa proposta sono sostanzialmente due: che il sistema pubblico sarebbe incapace di mantenere standard elevati di qualità editoriale, e che la competitività internazionale della scienza subirebbe un danno. Entrambe queste critiche, pur da prendere sul serio, appaiono deboli se confrontate con l’esperienza storica e con la logica della proposta. La prima obiezione, secondo cui solo gli editori commerciali sarebbero capaci di garantire professionalità editoriale, è smentita dall’esistenza stessa di riviste come PNAS, eLife o Royal Society Open Science, gestite da accademie o enti pubblici e pienamente competitive a livello globale. Nulla impedisce, se dotati di infrastrutture adeguate e personale qualificato, di mantenere o migliorare gli attuali standard. La qualità non dipende dalla proprietà privata, ma dalla progettazione razionale dei processi e dall’integrità della loro gestione. La seconda obiezione, relativa alla competitività internazionale, ignora che la dipendenza dalle metriche commerciali ha già oggi effetti distorsivi sulla qualità della ricerca. Un sistema di pubblicazione basato su qualità metodologica verificabile e accessibilità universale sarebbe, nel medio termine, un vantaggio competitivo per ogni sistema scientifico che voglia fondarsi sull’eccellenza reale, non su indicatori di prestigio artificiale. Liberare la scienza dai vincoli di mercato non significa provincializzarla: significa restituirla alla sua vocazione universale.
Nonostante le difficoltà, l’occasione di riprendere il controllo collettivo sui processi di certificazione della conoscenza scientifica è oggi troppo importante per essere lasciata cadere. Continuare a finanziare passivamente un sistema che ha smarrito la sua funzione pubblica significa accettare il declino progressivo della credibilità della scienza. Intervenire ora, con decisione e intelligenza, è l’unico modo per restituire alla comunicazione scientifica il suo ruolo essenziale: garantire la qualità, la trasparenza e l’accessibilità universale della conoscenza.
