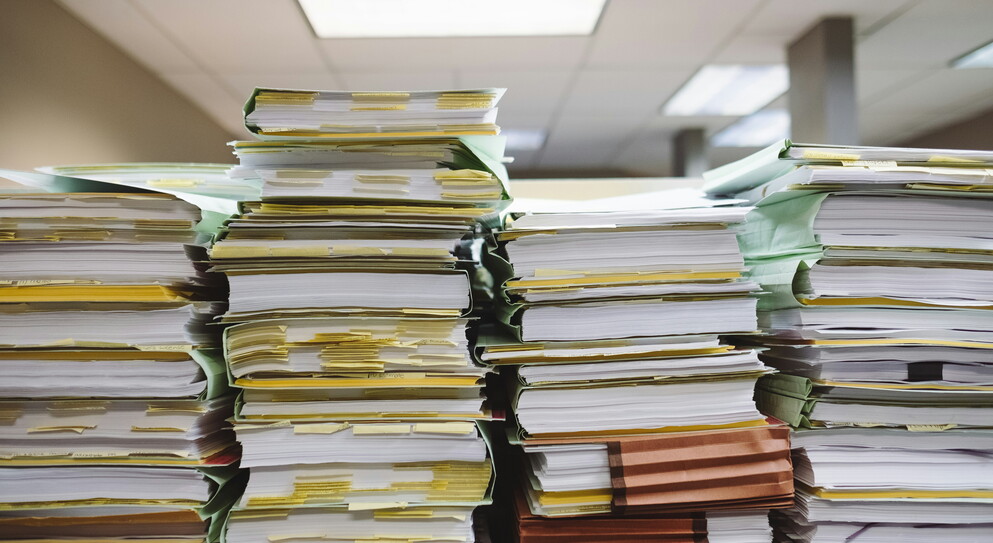In un mercato spinto da incentivi infiniti e costi marginali nulli, dove quantità e citazioni contano più della qualità, la degenerazione della letteratura scientifica alimenta pratiche distorsive e la crisi della ricerca si aggrava
La pubblicazione scientifica è diventata un mercato con caratteristiche mai viste altrove: incentivi potenzialmente infiniti sul lato della domanda, costi quasi nulli sul lato dell’offerta, assenza di vincoli materiali grazie al digitale, moltiplicabilità illimitata del “prodotto” articolo. Il risultato è un diluvio di lavori deboli, ridondanti o fraudolenti che abbassano il rapporto segnale/rumore della letteratura scientifica, divorano tempo di lettura e drenano risorse pubbliche senza restituire conoscenza proporzionata. È questo l’esito di incentivi che ha trasformato le pubblicazioni in mezzo per ottenere finanziamento e far carriera e gli indicatori citazionali da strumenti di misura a obiettivi.
Dal lato della domanda, la spinta a pubblicare non ha un punto di saturazione endogeno, perché la competizione è definita in termini relativi: si viene valutati rispetto ai pari, e i pari stanno cercando di incrementare i propri numeri. È un tapis roulant bibliometrico: per non arretrare occorre correre più degli altri, e ogni giro fa salire l’asticella. Questa dinamica si autoalimenta, creando dal punto di vista del mercato una situazione di domanda inesauribile e sempre in crescita – una condizione limite che non si osserva in nessun altro settore oltre quello dell’editoria scientifica. La spinta pubblicare di più dei propri competitori per fare carriera è una leva che piega i comportamenti verso la serialità, il “salami slicing”, la co–autorialità inflazionata, le reti citazionali. La domanda di articoli, quindi, cresce per ragioni estrinseche alla qualità scientifica: è solo un mezzo per stare al passo, e chi non accresce il proprio tesoretto citazionale resta presto indietro.
Dal lato dell’offerta, l’abbattimento dei costi marginali dovuto alla digitalizzazione ha rotto l’antico legame tra scarsità materiale e produzione editoriale. Non esistono più limiti fisici di carta, tipografia o distribuzione; i server scalano, l’indicizzazione degli articoli e dell’impatto citazionale è automatizzata, il copy–editing si comprime, la messa online è istantanea. Soprattutto, il lavoro più costoso – scrivere, revisionare, valutare – è fornito gratuitamente proprio da chi “acquista” il bene finale (l’avanzamento di carriera). La proprietà di una di queste aziende, in termini economici, ha costi quasi fissi e molto bassi rispetto al volume, e ottiene margini aggiuntivi per ogni articolo pubblicato: il modello rende quindi economicamente razionale spingere per la quantità. Il moltiplicatore dei numeri speciali – con reclutamento capillare di guest editor e call a tema – funziona da fabbrica just-in-time di offerta: si creano spazi di pubblicazione su misura per assorbire la domanda in eccesso, spesso comprimendo la qualità della peer review e la profondità editoriale. Dove la reputazione non basta, si compensano con l’indicizzazione rapida: l’inclusione in repertori citazionali agisce come certificato di commerciabilità del prodotto.
Sui prezzi, il mercato ha trovato l’equilibrio più pericoloso: il costo per il “consumatore” individuale, il ricercatore che pubblica, è spesso nullo. Le APC (il costo richiesto dalla rivista agli autori), i contratti trasformativi e le spese editoriali ricadono su fondi pubblici, progetti, istituzioni; l’autore non ha dunque il freno della spesa personale e, dovendo massimizzare l’output bibliometrico, sceglie canali che ottimizzano tempo e probabilità di accettazione. Anche quando i bilanci si fanno magri, l’industria non rallenta: semplicemente scivola verso soluzioni low-cost e high-throughput, fino ai confini dell’editoria predatoria e alle cartiere di manoscritti. In questi ultimi due casi, ma anche per ogni rivista di peggiore qualità a fronte di moltissimi articoli pubblicati, chi vende monetizza micropagamenti ripetuti su grandi volumi; chi compra socializza i costi e privatizza i benefici in punteggio bibliometrico. Ne nasce una piramide a due strategie vincenti e complementari: in alto pochi brand ad alto costo, che vendono “segnale reputazionale”; in basso una miriade di contenitori a basso costo, che vendono “probabilità di accettazione” e velocità. Entrambe prosperano perché l’incentivo a pubblicare è infinito e perché i costi marginali dell’offerta, nel digitale, sono prossimi allo zero.
Il sistema di controllo non è costruito per reggere questa pressione. La revisione dei pari è surclassata dal volume di manoscritti e, al contrario della sottomissione, è un lavoro privo di incentivi, per cui, nei casi in cui le riviste non l’abbiano in realtà già abbandonata, trovare revisori è difficilissimo e spesso si ricorre a chiunque di buona volontà, non agli esperti di settore. Gli indicizzatori delle riviste ai fini del calcolo degli indicatori bibliometrici sono filtri tardivi: ammettono, osservano, poi – quando emergono pratiche scorrette o standard scadenti – deindicizzano. Ma la latenza tra ingresso, accumulo di articoli/citazioni e sanzione crea finestre di arbitrio: nel frattempo, quelle sedi hanno già fornito a centinaia di autori titoli spendibili per soglie e concorsi. Quando il “certificato” di database come Scopus o PubMed cade, il vantaggio è incassato, e una costellazione di nuove testate, costruite con lo stesso software editoriale e spesso con lo stesso parterre, è già pronta a subentrare e a farsi indicizzare. Il risultato è un ricambio perpetuo che trasforma la deindicizzazione in un deterrente ed in un rimedio del tutto inefficaci. Vi è poi un’altra, ben peggiore conseguenza, quasi forse più grave della rovina della pubblicazione scientifica e della conoscenza ivi mantenuta. Infatti, questa architettura di incentivi e costi produce effetti di selezione dentro la stessa comunità accademica.
Chi massimizza a resa bibliometrica, è infatti promosso al controllo di risorse, reti e posizioni: co–autorialità di default dei capigruppo, accorpamenti strategici tra gruppi per scambiarsi citazioni, frammentazione dei risultati in serie, serializzazione di numeri speciali gestiti da cerchie vicine. I grafi di co–autorialità si piegano a logiche di potere; le curve di produzione dei docenti esplodono quando assumono incarichi; il significato di “contributo scientifico” si confonde con quello di “presenza nell’elenco degli autori”. È il trionfo della contabilità bibliometrica sul merito. E poiché la carriera delle ultime generazioni accademiche è stata filtrata così, attendersi che il sistema si riformi da sé è ingenuo: chi è stato selezionato da certe regole tenderà a riprodurle.
In questo quadro generale, l’Italia ha scelto di istituzionalizzare l’errore di fondo. Con l’abilitazione scientifica nazionale governata da mediane di produzione e impatto, calcolate sulla stessa popolazione che le deve inseguire, si è trasformata Goodhart in norma amministrativa: la misura ha perso significato nel momento in cui è diventata il cancello d’ingresso. Le mediane hanno reso razionale, per il singolo, ogni condotta che aumenti quantità e citazioni – indipendentemente dal valore intrinseco – perché ciò che conta è superare soglie mobili, ricalcolate proprio mentre vengono rincorse. Hanno spinto verso sedi facili, numeri speciali a catena, co–autorialità inflazionate, scambi citazionali: tutto ciò che fa crescere il contatore, come ormai studi sulla maniera di pubblicare in Italia cominciano a documentare. Hanno penalizzato chi lavora su problemi lenti o meno “citabili”, e premiato chi sa ottimizzare il meccanismo. Hanno insegnato a generazioni di ricercatori che la scienza è un flusso di PDF, non un corpus di risultati solidi.
Né vi è da sperare nel disegno di riforma attualmente in discussione, che abolisce sì l’abilitazione nazionale e il meccanismo delle mediane, ma lo sostituisce con un annunziato set di misure quantitative, selezionate da ANVUR, e con una piattaforma informatica “a semafori” del ministero – continuando, cioè, sostanzialmente a reiterare la valutazione basata sull’impatto citazionale, in un nuovo sistema semplicemente più arzigogolato e complesso.
È questo il punto: l’Italia ha reso strutturale la degenerazione del mercato editoriale legandola alla carriera accademica tramite meccanismi che sono particolarmente stringenti, e che infatti stanno già manifestando i loro effetti deleteri, in paragone ad altri paesi. Fino a quando quel legame non sarà reciso – abolendo l’impatto citazionale e la bibliometria come filtro – rimettendo in piedi sistemi di valutazione misti e meglio calibrati (come ad esempio in Olanda), rendendo irrilevante la produzione seriale in contenitori di dubbio valore e tracciando in modo rigoroso il contributo autoriale – continueremo ad alimentare un mercato perfetto per la quantità e pessimo per la verità, dirigendo un fiume di denaro pubblico verso un immondezzaio di carta virtuale.