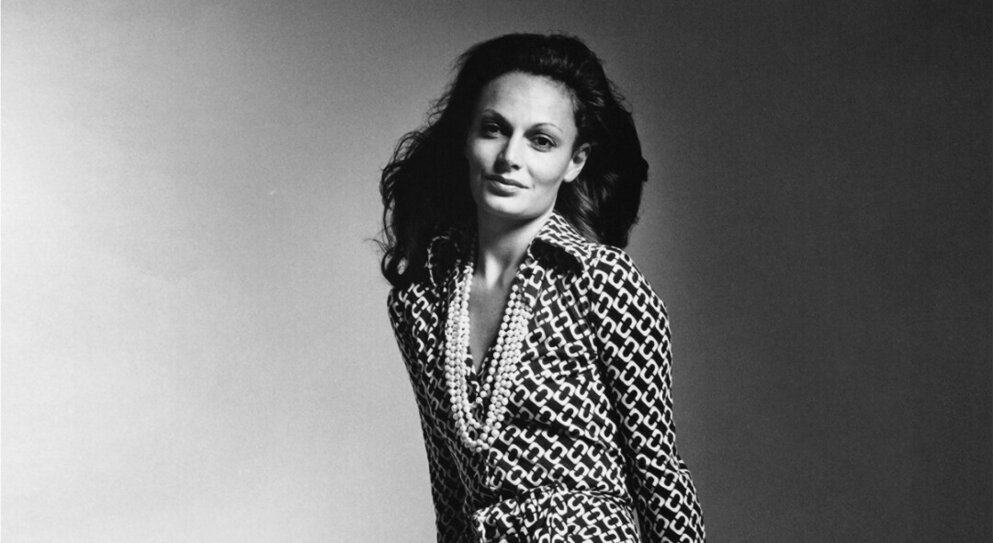Dopo anni di collezioni figlie dei desiderata dei mercati emergenti e delle tendenze di breve durata, da qualche tempo ci si è resi conto di come sia necessario riportare l’attenzione sui vestiti e sul loro capitale intrinseco di design e qualità
Il mese delle fashion week che sta per prendere il via sarà molto intenso e ricco di eventi, a partire da Milano con le sue cinquantacinque sfilate in programma, una in più della scorsa edizione. È un dato significativo che testimonia una ottima vivacità produttiva, pur in momento economicamente complesso e che, malgrado le assenze di Marni, Versace e Bally in fase di riorganizzazione interna, conterà esordi importanti: Louise Trotter da Bottega Veneta, Simone Bellotti da Jil Sander e il ritorno di Boss, The Attico, Stella Jean. A ogni pubblicazione del calendario della settimana della moda la constatazione che si tratterà inevitabilmente di un tour de force fra spostamenti impossibili e traffico ingestibile ci spinge a riproporre come un mantra il ritornello sulla inevitabile fatica che ci attende, fatica peraltro spesso non compensata dalla scoperta di una creatività dirompente.
Un entusiasmo così contenuto da parte degli operatori, pur con le ovvie eccezioni dei debutti che catalizzano l’attenzione e di brand imprescindibili, è frutto, in parte, della ripetitività di un format, quello della sfilata, che da anni è messo in discussione senza che ad essa si trovino valide alternative. A meno di non rivitalizzare la classica presentazione “statica” (il nome tecnico è poco seducente, ma tant’è), con tutti gli artifici scenici del caso ma senza l’obbligo del ritmo concitato che brucia il lavoro di molte settimane in pochi minuti di show. La scelta di Gucci per la prima prova di Demna (il designer più atteso della stagione milanese, con un forte carico di aspettative visive ed economiche), e cioè il rientrare in calendario con una presentazione dopo settimane di comunicazioni contrastanti, è stata sicuramente dettata da questioni strategiche e organizzative, cercando di bilanciare il tempo di acclimatamento del nuovo direttore artistico con la necessità di invertire un trend di vendite negativo attraverso un evento di forte richiamo; ma per quanto la scelta dello spazio più intimo nel quale mostrare i capi sia dovuta a cause di forza maggiore, questo non è da considerarsi un ripiego, anzi.
Da qualche tempo ci si è resi conto di come sia necessario riportare l’attenzione sui vestiti e sul loro capitale intrinseco di design e qualità, dopo anni di collezioni figlie dei desiderata dei mercati emergenti e/o alto spendenti e delle tendenze di breve durata. Quindi cosa c’è di meglio della possibilità di vedere da vicino tagli e tessuti, finishing e ricami per restituire valore al “prodotto abbigliamento”? La sfilata beneficia di uno storytelling che l’ha resa un genere quasi mitologico: una storia lunga più di un secolo, a partire dal 1903, anno nel quale gli Ehrich Brothers di Manhattan ne organizzarono una all’interno del loro negozio, e che ha raggiunto lo status di evento globale ben prima dello streaming attraverso il passaparola, il senso di esclusività degli ammessi al “rito”, la tensione palpabile e l’adrenalina sempre costante. Ma anche con le celebrities che sempre di più rubano la scena alle collezioni.
Senza contare che l’aura di eccezionalità dell’evento è diluita in un calendario che, tra menswear, womenswear, resort, couture e quant’altro, prevede un flusso semi-continuo di appuntamenti. La pletora di fashion show, oltre che difficile da gestire (abbiamo tutti commentato il numero esorbitante, a rischio burn out – di sfilate annuali in capo a Jonathan Anderson) sconta l’effetto livella nel quale i contenuti si susseguono in maniera omogenea, con picchi rappresentati più dalle sempre altissime aspettative di fatturato che dalle collezioni, troppo vincolate a input commerciali. L’alternativa della passerella digitale non ha mai sfondato, rincresce notarlo, ma i video di un designer di talento come Gareth Pugh, per quanto sembrassero avveniristici attorno agli anni ‘10 oggi appaiono irrimediabilmente datati, così come non hanno lasciato particolari tracce i recenti esperimenti di un marchio brillante come Coperni nel creare un’esperienza immersiva tra moda e videogaming.
È singolare che dopo più di un secolo sentiamo ancora il bisogno di una struttura narrativa in fondo così semplice come quella di una camminata tra due ali di pubblico, per quanto scenografie e contesto la possano rendere speciale, e quando, per contro, molte ci appaiano come esercizi routinari che si risolvono nel ribadire l’appartenenza del brand a un calendario prestigioso. Location più accoglienti e raccolte con la possibilità di creare allestimenti ugualmente appaganti e il giusto tempo per vedere i vestiti: forse è il tempo di una dieta che con un occhio ai costi riporti l’attenzione sul design che tanto abbiamo invocato nelle ultime stagioni. Una presentazione non è una sfilata mancata né, tantomeno, una natura morta di capi esposti con un approccio museale, ma qualcosa di più vicino a un guardaroba, a uno spazio personale nel quale valutare e scegliere.