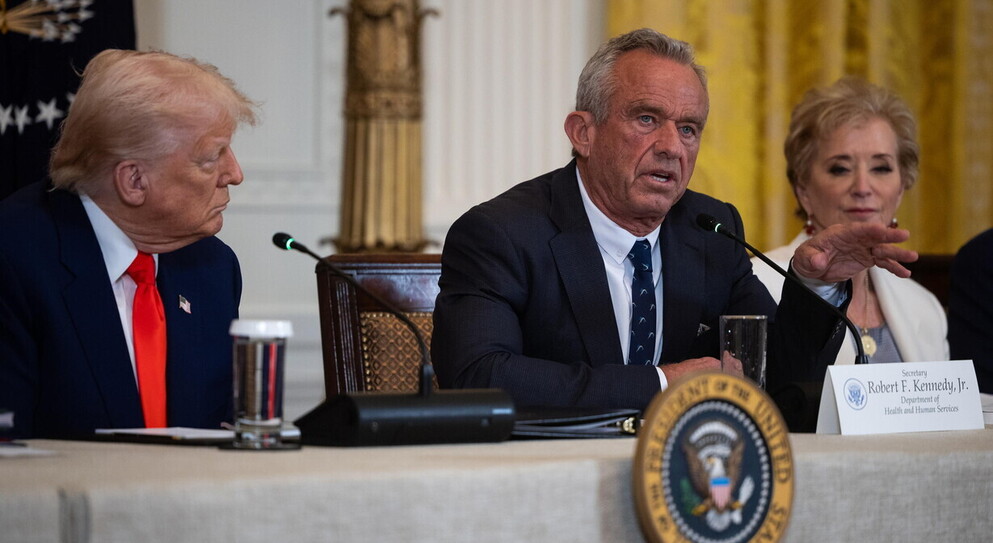Gli scienziati devono togliere terreno alla caricatura che rende fragile il loro lavoro ricucendo il legame con i cittadini, mostrando i passaggi del ragionamento, chiamando le incertezze per nome, rendendo visibile il processo che porta a una conclusione e i motivi per cui, talvolta, quella conclusione deve essere rivista
Perché alcuni fra noi si impegnano a divulgare la scienza? Perché, come argomenta Arthur Caplan in un recente editoriale, abbiamo contribuito noi stessi alla situazione in cui la scienza viene attaccata e pochi sentono il dovere di difenderla.
Caplan descrive senza giri di parole un paradosso: mentre la scienza produce risultati di enorme valore pubblico, negli Stati Uniti è sottoposta a un fuoco incrociato – federale e statale – che ne mina l’autonomia, tenta di intimidire le riviste, scredita gli scienziati nelle sedi istituzionali e li isola nell’opinione pubblica. Questo è anche l’esito di una colpa interna, coltivata a lungo. Nella comunità scientifica, abbiamo per secoli trattato la comunicazione come un’attività ancillare, opzionale, spesso sospetta. Abbiamo persino coniato un’etichetta sprezzante per chi prova a parlare con i cittadini: “saganizzazione”, dal grande scienziato e divulgatore Carl Sagan, che vide la sua carriera interrotta più volte proprio perché la sua attività presso il pubblico appariva “sospetta” ai colleghi. “Saganizzazione” è il marchio con cui si insinua che chi comunica non possa essere un ricercatore serio. È qui il punto dolente: se la cultura scientifica disincentiva il contatto con la società, non sorprende che, quando arrivano gli attacchi, la società non sappia riconoscere e proteggere il metodo che la tutela.
Caplan elenca effetti concreti di questa miopia. L’ostilità politica non si limita ai tweet: prende la forma di pressioni e incursioni nelle sedi della conoscenza, dall’azione di pubblici uffici verso le riviste mediche per ottenere documenti e influire sui processi editoriali, fino alla rimozione o marginalizzazione di competenze nelle strutture pubbliche. In parallelo, il lavoro degli scienziati viene raccontato da altri, spesso con il repertorio delle semplificazioni, degli slogan e dei sospetti. Quando il dibattito si sposta su quel terreno, la scienza, che vive di trasparenza metodologica, di prove cumulabili e di correzione degli errori, appare come un blocco opaco e arrogante. È in quel vuoto – creato dalla nostra latitanza – che prosperano le narrazioni ostili e le decisioni contro-evidenza. La “saganizzazione”, usata come stigma all’interno della comunità scientifica, diventa il segnale di una responsabilità collettiva: abbiamo reso costosa, in termini di carriera e reputazione, l’unica cosa che potrebbe renderci meno vulnerabili, e cioè spiegare chi siamo, come lavoriamo, dove sono i limiti e perché cambiare idea alla luce di nuove prove non è una debolezza ma la prova di forza del metodo.
La diagnosi è netta e riguarda tre livelli intrecciati. Il primo è culturale: finché giudicheremo la divulgazione con sufficienza, continueremo a offrire al pubblico l’immagine peggiore possibile di noi stessi. Il secondo è istituzionale: finché università, enti di ricerca e riviste non riconosceranno comunicazione e trasparenza come parte del mestiere, chi fa buona scienza continuerà a essere scoraggiato dal farla conoscere bene. Il terzo è politico: se non abbiamo radici sociali, se non c’è fiducia costruita nel tempo, ogni intervento legislativo o amministrativo che ci colpisce passerà senza incontrare resistenza informata. L’esito prevedibile di un’abitudine – parlare solo ai pari, dare per scontato che basti il circuito delle pubblicazioni specialistiche, ritenere che i fatti, prima o poi, si impongano da soli – ha condotto a credere che la comunicazione sia una roba riservata a chi, fallito nella ricerca, ha tempo da dedicare ad altre attività. Non è così. I fatti diventano bene comune solo se qualcuno si prende la responsabilità di renderli comprensibili, verificabili e pertinenti per la vita delle persone.
Ecco perché è necessario impegnarsi a divulgare la scienza: non si tratta di trasformare il lavoro scientifico in spettacolo (come purtroppo pure avviene), ma di togliere terreno alla caricatura che lo rende fragile. Divulgare, in questo senso, significa correggere la “stupidità” che Caplan rimprovera alla comunità scientifica: ricucire il legame con i cittadini, mostrare i passaggi del ragionamento, chiamare le incertezze per nome, rendere visibile il processo che porta a una conclusione e i motivi per cui, talvolta, quella conclusione deve essere rivista. È un lavoro lento e a tratti anche molto duro, vista la mole di insulti, di rabbia e di odio che suscita in chi della scienza è nemico, ma è l’unico che, quando arriva l’attacco, consenta a chi non è scienziato di riconoscere dove stanno i fatti e perché valgono.
La divulgazione è parte integrante delle responsabilità della comunità scientifica.
Alla mia domanda iniziale, la risposta è dunque semplice e, alla luce di quanto scrive Caplan, obbligata: mi impegno a divulgare perché l’assenza di divulgazione ha già presentato il conto; perché solo invertendo la cultura della “saganizzazione” possiamo costruire alleanze sociali capaci di difendere il metodo quando serve; perché spiegare bene è l’unico modo onesto di chiedere al pubblico la fiducia necessaria al prosperare dell’impresa scientifica.