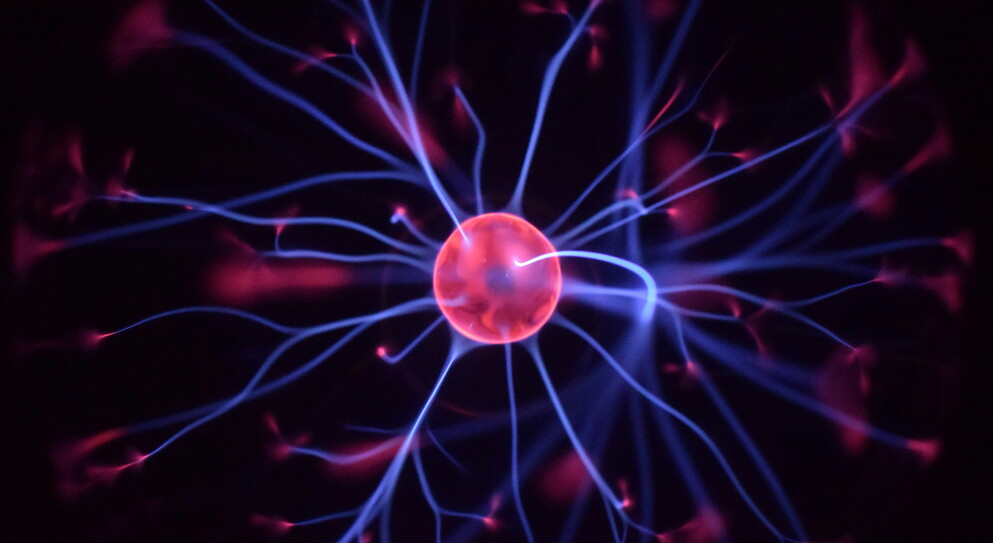L’aumento delle diagnosi di autismo riflette criteri più ampi e strumenti migliori, non una crescita reale dei casi. Ma le narrazioni pseudoscientifiche ignorano i dati e alimentano allarmi infondati
Per molte credenze pseudoscientifiche e cospirazionista, l’autismo è una condizione notoriamente usata come esempio di danno causato dalla propria tossina inventata preferita. Dopo la sua truffaldina connessione ai vaccini, operata da Wakefield, sono fiorite le teorie che la associano ad ognuno dei “cattivi immaginari” più diffusi: OGM, 5G, glifosate e così via inventando. Alla base delle “dimostrazioni” dei proponenti di simili fandonie già dimostrate false, vi è la radicata convinzione che si è in presenza di una vera epidemia di autismo, spiegabile solo invocando il “veleno” prescelto; non a caso, il più potente rappresentante di questo tipo di bugie, il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha presentato il 16 aprile come “epidemia” l’aumento delle diagnosi di disturbo dello spettro autistico, citando il passaggio da un bambino su centocinquanta diagnosticato nel 2000 a uno su trentuno nel 2022, e attribuendolo a una generica “tossina ambientale” da identificare con uno studio ad hoc. Un mese più tardi, il National Institutes of Health ha annunciato l’Autism Data Science Initiative, fino a cinquanta milioni di dollari per ricerche sulle cause, con i progetti vincitori attesi a settembre. Vale la pena di fare il punto, e l’occasione è un buon articolo apparso su Nature, di cui riporto di seguito gli argomenti principali.
La reazione del mondo scientifico non è stata di entusiasmo: decenni di lavori mostrano che l’aumento osservato riflette soprattutto il salto di capacità diagnostica, non una crescita parallela e sostanziale dei sintomi nella popolazione. La curva sale in molti Paesi ad alto reddito — Regno Unito, Danimarca, Corea del Sud, Giappone — e dove i servizi sono scarsi o i dati mancano la prevalenza è difficile da misurare. In Usa, le differenze marcate tra i vari stati sono spiegate dagli esperti prima di tutto con la diversa capacità di individuazione e con la disponibilità di percorsi diagnostici, non con brusche differenze epidemiologiche. Quando si passa da registri e archivi a indagini di popolazione, campionando sistematicamente bambini o adulti con strumenti standardizzati, l’immagine si fa più solida: la stima globale più recente indica circa una persona su centoventisette nel 2021. In Svezia, in una coorte seguita fino ai diciotto anni, i sintomi riferiti dai genitori restano stabili mentre crescono solo le diagnosi registrate; e l’aumento riguarda perlopiù soggetti senza disabilità intellettiva o gravi compromissioni del linguaggio, mentre i casi più severi non mostrano impennate.
Il motore principale di questa “epidemia di diagnosi” è tracciabile: tra inizio anni Novanta e 2013 i manuali di riferimento hanno allargato definizioni e spettro d’età (ICD-10 nel 1990 e DSM-IV nel 1994), fino a riassorbire nel DSM-5 la sindrome di Asperger e altre etichette sotto un’unica categoria; nel frattempo sono entrati nella pratica strumenti più strutturati (interviste e osservazioni standardizzate), è sceso lo stigma in scuole e ambulatori, sono aumentati servizi e incentivi all’identificazione precoce, sono emersi gli adulti fin lì invisibili e, soprattutto, le donne e le ragazze prima sottodiagnosticate. Anche l’ambiente di apprendimento, oggi più complesso e digitalizzato, spinge famiglie e insegnanti a cercare valutazioni per tratti lievi che un tempo restavano sotto traccia. Una stima danese, misurando l’effetto dei cambiamenti nei criteri e nelle notifiche su nati tra il 1980 e il 1991, attribuisce a questi soli fattori circa il sessanta per cento dell’incremento. Anche se esistono risultati che obbligano a non chiudere la porta a un contributo, limitato, di aumento reale della prevalenza – un’indagine giapponese del 2020, con metodi di rilevazione rigorosi, ha misurato oltre il tre per cento fra i cinque anni d’età – il quadro complessivo resta netto: la grande maggioranza della crescita è spiegata dall’espansione e dal perfezionamento della diagnosi.
Quanto alle cause, la ripartizione dei pesi è altrettanto chiara. La genetica domina: la quota di variabilità dei tratti autistici spiegata da fattori ereditari è intorno all’ottanta per cento, in media su più Paesi; tra il dieci e il venti per cento degli individui nello spettro presenta varianti rare a grande effetto, spesso mutazioni de novo sorte nel gamete e trasmesse al figlio. Accanto a queste, centinaia o migliaia di varianti comuni, ciascuna con effetto minimo, sommano il rischio fino alla soglia clinica in specifiche combinazioni individuali: un’architettura eterogenea per definizione, diversa da persona a persona. I fattori ambientali sono la fetta più piccola della torta e agiscono per lo più prima della nascita: l’età avanzata di madre o padre è associata a una probabilità più alta di diagnosi nel figlio — verosimilmente per via dell’aumento di mutazioni de novo con l’età — diverse infezioni in gravidanza risultano correlate a un incremento del rischio, e associazioni emergono per l’esposizione prenatale all’inquinamento atmosferico. In uno studio statunitense recente, oltre ottomila diadi madre-figlio hanno mostrato un’associazione con livelli più elevati di ozono. Su un punto, la letteratura è definita “convincente” da tutti gli autori degli studi citati: non esiste alcun legame tra vaccini e autismo, e l’ipotesi è stata ripetutamente confutata.
Nonostante queste prove, Kennedy parla di “epidemia” e come sempre cita numeri a caso. In maniera ancora più preoccupante, inoltre, nella stessa conferenza stampa citata in apertura, Kennedy ha descritto i bambini autistici come destinati a “non pagare mai le tasse” e “a non avere un lavoro”: parole che hanno indignato persone autistiche e associazioni, non solo perché false — moltissimi adulti nello spettro lavorano e versano imposte — ma perché svalutano in radice la dignità dei diretti interessati. A questo si sommano le preoccupazioni per tagli e rinvii di finanziamenti all’assistenza e alla ricerca sull’autismo, che colpiscono progetti essenziali proprio mentre si invoca una crociata contro un presunto tossico ambientale. I fatti disponibili raccontano un fenomeno complesso, con una parte minima forse ancora da spiegare e una parte massima che è già spiegata: ampliare criteri, strumenti e accesso ha ampliato lo sguardo; la genetica pesa molto più dell’ambiente; i vaccini non c’entrano. Il resto è propaganda che ignora le risposte faticosamente costruite in decenni di lavoro.