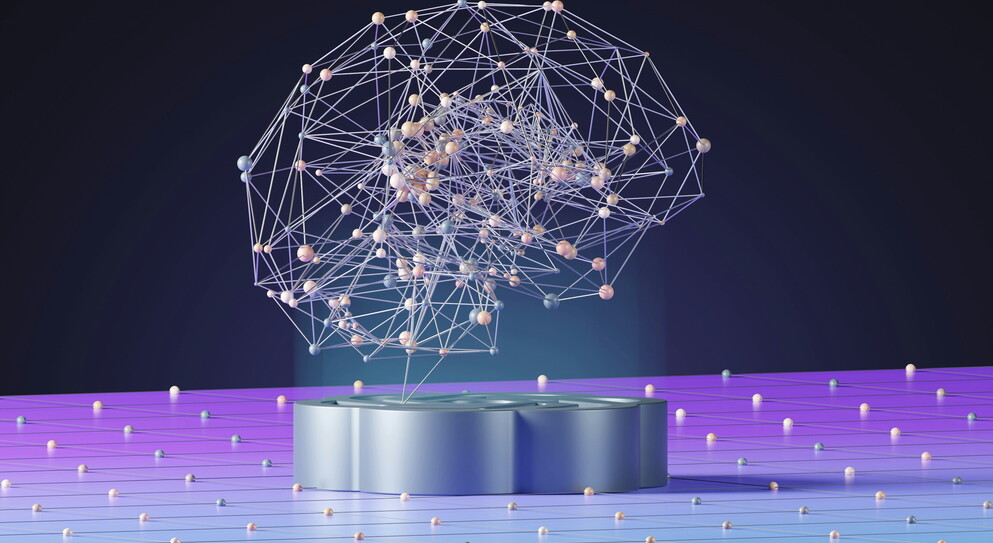Impegnarsi a far fruttare i nostri talenti per non trasformare l’AI in un pericoloso fattore di intorpidimento progressivo e in un moltiplicatore di stupidità: un insegnamento che proviene da Gesù
Tutti conoscono, credo, le parole rivolte da Gesù a coloro che non sono stati capaci di far fruttare i talenti ricevuti: “A chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Enigmatiche e dure quanto si vuole, queste parole esortano a non perdere mai di vista ciò che nella vita conta per davvero, quindi a coltivare la saggezza che ci consente di fare il nostro meglio nelle situazioni più diverse, ad avere fiducia, a tenere la mente sveglia di fronte alla realtà, tanto più questa è complessa, a non accontentarsi e, soprattutto, ad avere fede: la prospettiva che ne illumina il senso più vero e più profondo.
Laicamente parlando, potremmo leggere la parabola come un’importante apertura di credito nei confronti della nostra intelligenza e della nostra responsabilità: vigilate, ma non abbiate paura, aprite i vostri cuori e le vostre menti, utilizzate al meglio i talenti che avete, moltiplicateli, altrimenti, oltre a non cogliere le opportunità che la vita vi offre, perderete anche quelli, farete insomma la fine del servo timoroso che, anziché preoccuparsi di far fruttare la moneta che ha ricevuto, la sotterra per non correre rischi e restituirla intatta al padrone.
Ovvio che il vero significato delle parole di Gesù è escatologico, ma proprio per questo può essere esteso ben oltre i limiti della parabola che le contiene. Starei per dire che esse valgono per ogni vicenda umana. Sarebbe tuttavia sciocco supporre, ad esempio, che abbiamo in abbondanza, perché lo abbiamo meritato coltivando l’essenziale, e che il nostro vicino non ha nulla perché non l’ha fatto e quindi gli è stato tolto anche il poco che aveva. Soltanto Iddio conosce il nostro cuore, le nostre capacità e i nostri meriti. A ciascuno di noi viene chiesto soltanto di impegnarci a coltivare al meglio i nostri talenti con la fondata fiducia di ricavarne frutti buoni per noi stessi e per gli altri, ma senza alcuna certezza. A maggior ragione in una società ipercomplessa come quella nella quale ci troviamo a vivere, dove digitale e intelligenze artificiali danzano ormai il loro tripudium. Qui davvero dovremmo far tesoro del monito di Gesù.
Abbiamo costruito “strumenti” straordinari che facilitano e potrebbero facilitare sempre di più la nostra vita, rendendo quasi obsoleta la millenaria battaglia per i cosiddetti beni materiali e liberando tempo per coltivare i beni immateriali, relazionali, le attività ricreative, creative, solidali. Ma ovunque volgiamo lo sguardo siamo come sopraffatti della paura che questi potenti strumenti possano rivoltarsi contro di noi, diciamo pure, possano emanciparsi dal nostro controllo e dai nostri fini. Psicologi e neuroscienziati ci dicono, ad esempio, che certi strumenti digitali, se utilizzati troppo precocemente, rischiano di provocare gravi danni in certe aree del cervello, disturbi di apprendimento, nonché isolamento e disturbi depressivi. Il Massachussets Institute of Technology di Boston, tanto per fare un altro esempio, ha pubblicato recentemente il risultato di una ricerca sperimentale, intitolata “Il tuo cervello e ChatGPT: accumulazione e debito cognitivo nell’usare un assistente di intelligenza artificiale per compiti di scrittura”, stando alla quale l’uso di ChatGPT potrebbe ridurre del 55 per cento la connettività cerebrale (ne ha parlato Federico Fubini sul Corriere della Sera del 20 giugno scorso). Per non dire dei problemi, ormai arcinoti, che l’intelligenza artificiale potrebbe avere sul piano politico, economico o militare, sui quali veniamo ormai assillati ogni giorno.

Non sono problemi da poco, sia chiaro. Ciò che però mi sembra interessante sottolineare è qualcosa che li accomuna tutti e che potrebbe aiutarci a inquadrarli in una prospettiva che, per quanto preoccupante, li riconduce comunque alla nostra responsabilità. Sarà banale dirlo, ma è solo perché abbiamo abdicato alla nostra intelligenza naturale che dobbiamo fare i conti con i danni procurati sui bambini e sugli adolescenti dall’uso precoce degli strumenti digitali. Lo stesso possiamo dire per i danni che l’uso di ChatGPT potrebbe avere per chi non si è esercitato abbastanza a scrivere usando semplicemente il proprio cervello. In ogni caso questo è soltanto un lato del discorso. Bisogna anche dire infatti, che più i bambini sviluppano le loro capacità cognitive, immaginative e relazionali lontani da un video e più riescono poi a trasformare gli stessi strumenti digitali in una grande opportunità. Più saranno le persone che utilizzeranno ChatGPT dopo aver imparato a pensare, scrivere e lavorare in autonomia, più ChatGPT potrà rappresentare un potenziamento straordinario delle loro capacità. Ce lo dice anche la ricerca del MIT cui facevo riferimento.
Anche in questi ambiti insomma tutto fa pensare che “a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Banalizzando un po’, le intelligenze artificiali ci dicono in sostanza che per sfruttarle al meglio non dobbiamo smettere di coltivare l’intelligenza naturale; diversamente esse potrebbero diventare un pericoloso fattore di intorpidimento progressivo, diciamo pure, un moltiplicatore di stupidità. Per ovviare a tutto questo, dovremo certo impegnarci a ripensare gran parte delle nostre politiche educative, a sensibilizzare le famiglie e le nostre opinioni pubbliche, ma non mi sembra una mission impossible.