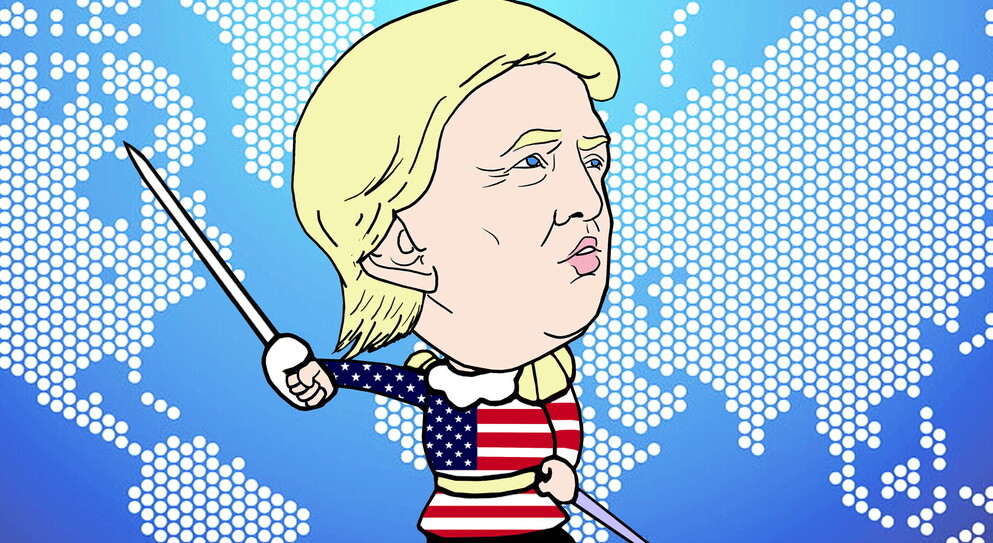La guerra commerciale non serve né agli americani né a noi europei. Piuttosto che rispondere con la stessa moneta, servono trattati di libero commercio con le economie emergenti. E servono subito
È praticamente ininterrotta, sia la convulsa serie di annunci di Trump di nuovi dazi, sia la loro diluizione o sospensione a tempo. Mentre vengono scritte queste righe, la malcerta situazione è la seguente: dalla nuova Amministrazione americana risultano adottati dazi prima del 10 per cento e poi innalzati al 20 per cento su praticamente tutti i prodotti importati dalla Cina, la sberla del 25 per cento di dazi sui prodotti da Canada e Messico è stata poi congelata per un mese sui beni coperti dall’accordo commerciale nordamericano Usmca, i dazi globali del 25 per cento su acciaio e alluminio sono in vigore dal 12 marzo, e il 26 marzo è arrivato l’annuncio di Trump di dazi globali del 25 per cento su qualunque auto estera importata negli Usa. Al momento sembra che la componentistica automotive estera sia esclusa dai dazi, per non appesantire troppo i costi dei produttori di auto statunitensi che ne sono in realtà dipendenti. Gli Stati Uniti nel 2024 hanno importato auto estere per 290 miliardi di dollari, e componentistica per 179 miliardi. Per oggi, 2 aprile, indicato da Trump come “giornata di liberazione degli Stati Uniti da chi ci maltratta nel commercio”, ancora non è chiaro che cosa davvero attendersi. Di fronte a questo sabba di annunci e contro annunci, è ovvio che i mercati finanziari mondiali accentuino reazioni e tensioni. La fiducia e la capacità di nutrire fondate aspettative vanno a ramengo, grazie alla mercuriale imprevedibilità di Trump. Altrettanto diverse sono sin qui le reazioni dei governi dei maggiori paesi la cui produzione è colpita dal mercantilismo aggressivo di Trump. Vedremo alla fine di questa riflessione che cosa davvero convenga fare, ma come al solito per capire meglio ciò che sta avvenendo bisogna fare diversi passi indietro.
Tutto nasce nel 2009, quando Obama si rende conto che l’ingresso della Cina nel Wto è stato un maxi favore
Trump e la sua gang sono solo la punta più avanzata e irresponsabile di un disegno che gli Stati Uniti hanno in realtà coltivato da molti anni a questa parte, sotto tutte le amministrazioni susseguitesi. Una puntuta e argomentata sintesi la trovate nel saggio recentemente pubblicato su Foreign Affairs da Michael Froman, che ha servito diversi presidenti americani come delegato tecnico o consigliere sui temi del commercio mondiale: insomma, un tipo che sa bene di che cosa si parli.
Tutto nasce nel 2009, l’anno in cui l’Amministrazione Obama si rende conto che l’ingresso della Cina nel Wto in 10 anni si è trasformato in un maxi favore unilaterale. Pechino non ci pensa proprio a smettere la sua predazione di proprietà intellettuale in tutto il mondo occidentale per accrescere specializzazione e innovazione tecnologica della propria manifattura, né smette di praticare frodi commerciali su scala sempre più vasta. Per questo gli Stati Uniti bloccano allora il Doha Round e frenano da quel momento qualunque passo strategico in avanti del Wto, lasciandolo anche senza procedure arbitrali davvero efficaci per mettere al bando e punire le violazioni cinesi. Washington, sotto la guida dei democratici, lancia IL Tpp, uno schema di trattato di libero commercio esteso a 12 paesi del Pacifico che nasce come cintura protettiva e alternativa al libero commercio con la Cina. L’intesa poi naufraga anch’essa, dopo anni di trattative. E nel 2015 gli Usa abbandonano anche quel tavolo. Nel frattempo, la crescita Cina è esplosa. Il pil di Pechino è cresciuto dai 348 miliardi di dollari del 1989 ai 1.600 miliardi di dollari del 2003, per giungere poi nel 2023 a 17,8 mila miliardi di dollari. Nel 2009 la Cina alimentava ancora solo il 9 per cento del valore aggiunto nel commercio mondiale. Nel 2023 ha superato il 30 per cento. Negli anni di Xi Jinping, prima della frenata dell’ultimo biennio, il suo export annuale continuava a crescere con un multiplo di 3 rispetto alla crescita del commercio globale. La Cina non è solo la fabbrica del mondo: oggi come capacità produttiva potenziale sarebbe in grado di coprire quasi i due terzi della domanda mondiale di auto. Il suo potenziale produttivo ormai supera il 50 per cento dell’offerta globale in settori come acciaio, alluminio e cantieristica navale.
Washington era nell’angolo, incapace di darsi una strategia efficace e di proporla all’intero occidente
Nella seconda metà del primo decennio del Duemila, Washington rimase sempre più nell’angolo, incapace di darsi una strategia efficace e di proporla all’Europa e all’intero occidente. Di lì venne poi la decisione di Trump nel suo primo mandato: accrescere dal 3 al 19 per cento i dazi su due terzi di tutto l’import dalla Cina negli Stati Uniti. La scelta fu quella di rispondere con le maniere forti a chi sin lì aveva fatto il furbo: non solo coi dazi per colpire la Cina sul suo export, ma anche adottando politiche cinesi con super sussidi di stato alla propria produzione nazionale, prassi che Pechino non ha mai dismesso. I democratici americani, con buona pace di chi oggi urla contro Trump-Nerone, si accodarono in tutto e per tutto. Il presidente Biden non solo confermò i dazi di Trump, ma li estese a nuove categorie di prodotti. E con Biden i maxi incentivi di stato alla manifattura e alle nuove tecnologie solo made in Usa sono diventati stellari, ai massimo storici tranne gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2023 la somma di sussidi pluriennali, con l’Inflation Reduction Act, Chips Act e misure per il potenziamento delle infrastrutture, ha fatto salire gli aiuti di stato statunitensi fino alla stellare cifra di 1.600 miliardi di dollari.
Dazi e protezionismo verso il made in Usa sono sempre stati giustificati da tutti i presidenti con un eguale ritornello: dobbiamo riportare negli States la produzione industriale che ha scelto di globalizzarsi andando altrove, sottraendoci occupati, export ed entrate fiscali. Un’alta pila di ricerche e studi economici sugli effetti concreti nella manifattura statunitense della prima ondata di dazi adottata da Trump nel 2018-19 non ha mai trovato però alcuna conferma di questa conseguenza positiva, che da Washington i presidenti predicavano come certa. Anzi: tra il 2018 e il 2020 gli occupati nella manifattura americana continuarono a scendere di quasi 80 mila unità. Né ci furono aumenti di produttività, se non quelli determinati dalle grandi piattaforme tecnologiche digitali, che sono giustamente il vanto dell’economia mondiale nel mondo. Quegli aumenti di produttività sarebbero avvenuti comunque, a prescindere da dazi e sussidi di stato. Nel settore dell’acciaio, iper protetto dai dazi di Trump nel suo primo come nell’attuale secondo mandato agli inizi, la produttività oraria degli impianti statunitensi è caduta del 32 per cento. E sia Biden sia Trump si sono opposti brutalmente a Nippon Steel che voleva rilevare la statunitense US Steel, malgrado a giudizio di tutti gli analisti i capitali freschi e una superiore cultura manageriale dei giapponesi sarebbero stati un toccasana per la malconcia impresa americana.
Nel frattempo, sotto la leadership cinese attuale, gli spazi per investimenti esteri non soggetti a joint venture controllate da Pechino diminuiva sempre di più, e partivano nuovi maxi programmi di stato per accrescere l’eccellenza su tutte le tecnologie avanzate nel settore della transizione green come in quella digitale e dell’intelligenza artificiale. Oggi la Cina è molto più ricentrata su se stessa e nella ridefinizione nel sud-est asiatico e nell’area della Belt and Road Initiative delle proprie catene di fornitura, di quanto fosse in precedenza dipendente dall’export verso gli Usa. Nell’ultimo decennio anche la sua quota un tempo massiccia di Treasuries del debito pubblico Usa si è praticamente dimezzata. Gli investimenti diretti della Cina negli Stati Uniti sono scesi dai 46 miliardi di dollari del 2016 a meno di 5 miliardi nel 2022.
In sintesi, la Cina ha spettacolarmente approfittato al meglio di tutte le concessioni occidentali e in primis statunitensi, moltiplicando volumi e resilienza di tutti i settori della propria manifattura e accrescendone in maniera sempre più intensiva le capacità e le applicazioni tecnologiche. Il tutto mentre la presa del regime comunista su economia e piani di sviluppo, società e libertà si è accresciuta esponenzialmente. Oggi Pechino deve affrontare problemi di sovracapacità e i costanti rischi rappresentati da un sistema del credito-ombra che falsa ogni prospettiva di resilienza finanziaria del paese. Ma il suo balzo in avanti spettacolare è realizzato e continua a tutto vapore: nell’auto i suoi prodotti non hanno solo costi molto più bassi di quelli europei, sono più tecnologicamente avanzati e persino competitivi per design e finiture.
Messico, India, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Mercosur, Sud Africa. E’ a loro che Italia e Ue devono guardare
Tutti questi precedenti storici impongono una domanda. Davvero oggi Stati Uniti ed Europa, dopo aver tenuto gli occhi chiusi per decenni sulle mancate promesse dei cinesi, credono che la risposta efficace sia farsi guerra a vicenda adottando super dazi incrociati e protezionismo fortissimo, segregando le proprie manifatture e tecnologie? La risposta possibile è una sola. E’ un errore strategico. Né la manifattura statunitense né quella europea hanno oggi forza e leve paragonabili a quelle della Cina. Indebolendosi gli uni con gli altri, americani ed europei farebbero ancora una volta un gioco che ha un unico vincitore, sempre lo stesso degli ultimi decenni: la Cina. Trump può ben vantarsi di aver attirato negli Stati Uniti in questi ultimi due mesi muscolari grandi investimenti industriali di gruppi esteri che rispondono alla manaccia della Casa Bianca – “investite negli Stati Uniti se volete uno scudo ai dazi” –, come nel caso dei giapponesi di SoftBank o della Hyundai sudcoreana. Ma questo non sana né i ritardi tecnologici e di produttività della manifattura statunitense, che è più indietro di quella europea nelle piccole e medie imprese, né aprono alcuna prospettiva interessante per l’Europa. Che farebbe dunque bene a evitare ogni reciprocità bellica sui dazi annunciati da Trump: l’orgoglio di sembrare iper reattivi porta a vere fesserie, come l’ipotesi ventilata di dazi europei sul bourbon, che hanno spinto Trump a minacciare dazi del 200 per cento sul nostro vino. All’Italia e all’Europa conviene tutt’altra strategia. Buttarsi a corpo morto nella trattativa e firma in tempi rapidi di una serie di intese di libero commercio verso paesi come Messico, India, Indonesia, Thailandia, Vietnam, tutta l’area del Mercosur, Sud Africa e i paesi Emea più stabili. Confindustria e governo italiano indicano propria questa prospettiva: ma bisogna essere pronti a percorrerla come Italia, se l’Unione europea tergiversa, perché nei tre anni a venire non si può restare esposti al sisma Trump credendo che lo scudo efficace siano alti dazi versi i prodotti americani.