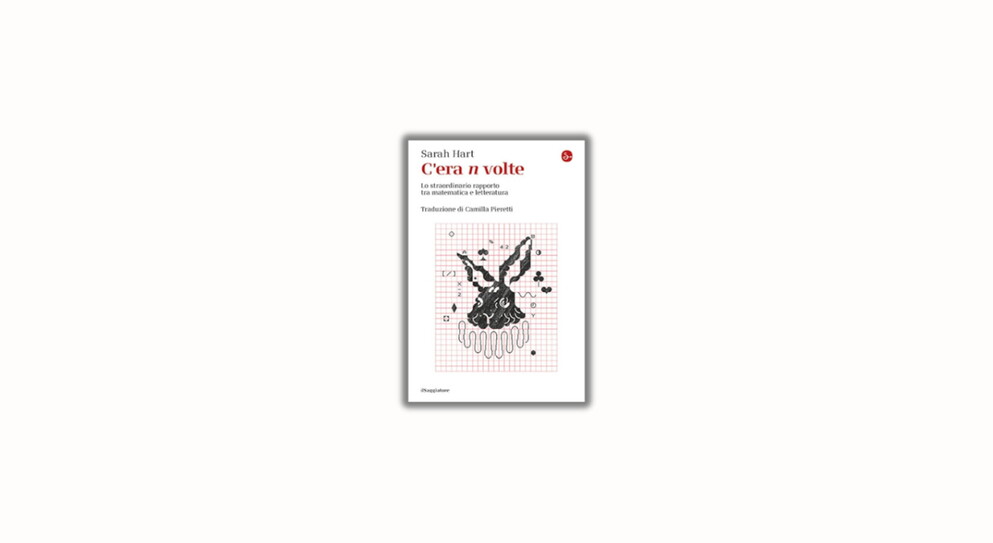La recensione del libro di Sarah Hart edito da il Saggiatore, 360 pp., 26 euro
Se qualcuno pensasse che letteratura e matematica siano mondi estranei, questo è il libro giusto per fargli cambiare parere. Sarah Hart è di professione matematica (tra l’altro nel 2020 è stata la prima donna a salire sulla cattedra di geometria del Gresham college di Londra dai tempi della sua fondazione nel 1597), e fin da piccola la sua passione per schemi e regolarità l’ha portata a cercarli tanto fra i numeri quanto nei testi. E ora offre al lettore un’allegra scorribanda lungo il confine fra due mondi, condotta in modo rigoroso ma con tono sempre lieve e scanzonato (e non di rado autoironico).
C’è della matematica, ovviamente, nelle strutture poetiche, dai ritmi delle filastrocche infantili alla metrica delle forme poetiche più complesse, da Dante a Shakespeare; ma c’è della letteratura nei modi in cui gli antichi matematici indiani presentavano i loro teoremi, e anche nella matematica di oggi: “Quando abbiamo bisogno di nuove parole per definire qualche elemento, ci affidiamo alle metafore”. C’è della matematica nelle strutture di tanta letteratura contemporanea, che costruisce coi numeri l’architettura di romanzi e racconti, talvolta per suggerire percorsi di lettura alternativi; ma c’è tanta matematica anche nelle pagine di capolavori del canone letterario, da George Eliot a Tolstoj, da Melville a Joyce: Eliot dedica alcuni dei suoi romanzi più noti a caos e probabilità, Tolstoj infila un’equazione al cuore di Guerra e pace; Melville usa in Moby Dick un’infinità di metafore matematiche, Joyce costruisce un intero capitolo di Ulisse (il settimo, Itaca) nelle forme di un dialogo matematico. Per non dire dei calcoli meticolosi di cui straripano i Racconti di Gulliver o della logica dei racconti di Poe o di Sherlock Holmes (l’unico che dall’esame di Hart esce un po’ malconcio è Dan Brown).
La lista potrebbe continuare all’infinito (beh, all’infinito proprio no, o forse in un certo senso sì, leggere le pagine su Borges), ma qui lo spazio è finto. Perciò, per chiudere, la chiave del libro: “La sensazione che si prova quando si legge un bel romanzo o un sonetto ben cadenzato è la stessa provata da un matematico di fronte a una bella dimostrazione. Per citare G. H. Hardy: ‘Il matematico, come il pittore e il poeta, è un creatore di forme. Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle; le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza e il requisito fondamentale’”.
Sarah Hart
C’era n volte
il Saggiatore, 360 pp., 26 euro