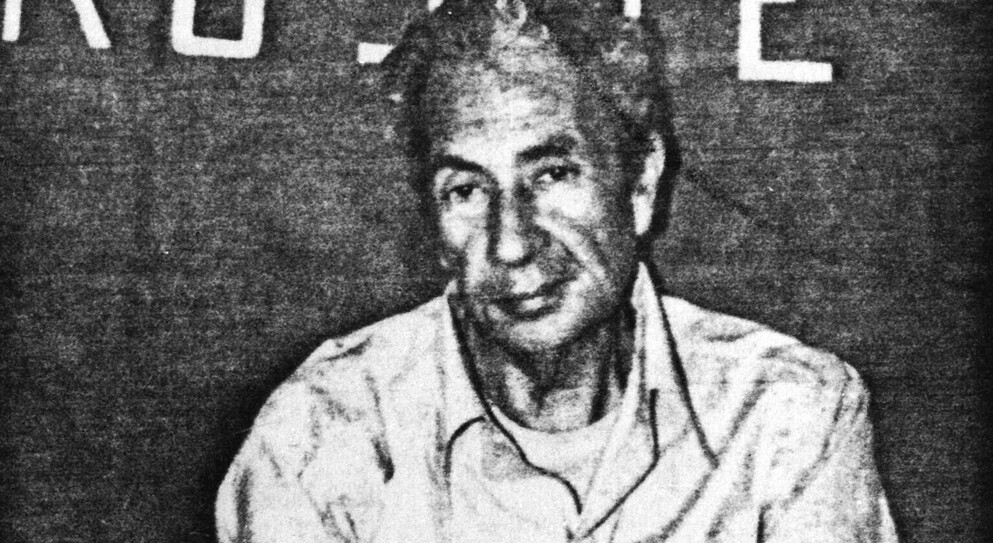Quanti connazionali hanno riflessi condizionati melodrammatici: davanti a un caso di cronaca attualissimo, pensano che la cosa migliore sia resuscitare retoricamente sulla scena i dilemmi morali che li agitarono allora
La pausa natalizia ha dissestato il mio senso del tempo. Apro i giornali italiani dopo alcuni giorni di sospensione e scopro di avere nove anni anziché quarantanove. E’ un ottobre di metà anni Ottanta, e tutti parlano di Sigonella, di orgoglio nazionale, di come preservare la dignità a cospetto del grande alleato americano. Quasi quasi stasera guardo Arbore in tv. Anzi, forse sono ancora più piccolo, non ho nemmeno tre anni, e intorno a me sento i grandi accalorarsi per un onorevole rapito di cui conosco a malapena il nome. Usano di continuo due parole misteriose: trattativa o fermezza, trattativa o fermezza. Davanti all’evocazione di quei due casi – il rapimento Moro, la crisi di Sigonella – molti connazionali hanno riflessi condizionati melodrammatici, e pensano che la cosa migliore sia resuscitare retoricamente sulla scena i dilemmi morali che li agitarono allora. Dunque gridano, gesticolano, piagnucolano, fremono. Poi metto il naso fuori dalla stampa italica e questo effetto di disallineamento temporale per miracolo svanisce: il mio mezzo secolo di vita mi piomba di nuovo addosso e mi trovo a leggere con infinita pena, la stessa pena che mi tiene in ostaggio da venti giorni, ciò che si sa e si prevede della sorte di un’amica carissima. Il silenzio stampa chiesto dalla famiglia è pressoché impossibile da ottenere, ma che si usi almeno la sordina; e non per disertare i doveri dell’informazione, ma perché i nostri melodrammi in playback, registrati nel 1978 o nel 1985, non servono a nulla, non spiegano nulla, non aiutano nessuno.