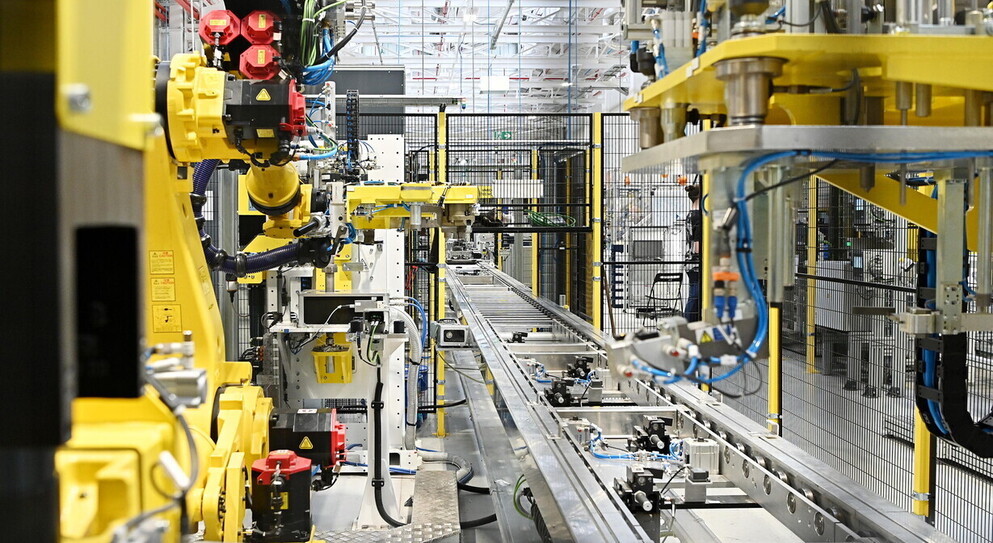La perdita di competitività non verrà compensata dal genio italiano. Tre proposte concrete per ripartire
Siamo un Paese iperindebitato che si regge grazie alla sua posizione finanziaria attiva sull’estero realizzata grazie all’export manifatturiero. Un paese trasformatore ad alto tasso di dipendenza su energia e materie prime strategiche. Grazie a un mix scellerato di fonti energetiche deciso e mantenuto per decenni abbiamo costi della bolletta elettrica tra metà e un terzo superiori di quelli dei maggiori paesi manifatturieri europei, e multipli rispetto a quelli di Stati Uniti e Cina. Per un paese così, crescita della produttività e del valore aggiunto dovrebbero costituire una bussola permanente della politica economica, anzi una vera e propria ossessione. Senza, non si regge il confronto sui mercati internazionali. Eppure no, in Italia su produttività e valore aggiunto continuiamo a far spallucce. Ne ha già scritto su queste colonne Dario Di Vico, attonito di fronte al silenzio generale della politica, imprese, sindacati e informazione sui dati rilasciati da ISTAT il 9 gennaio scorso. Ma è il caso di tornarci sopra. Perché questo silenzio è figlio delle politiche economiche sbagliate che l’Italia continua a replicare, verso le quali gli attori sociali esitano o non hanno interesse a obiettare, e di cui i media italiani restano inspiegabilmente prigionieri. Aiutando i populismi prevalenti nella destra e nella sinistra italiana.
I dati riguardano il 2023, e per quelli del 2024 bisognerà aspettare un altro anno. Ma è un grave errore credere che la voragine apertasi nel 2023 sia un episodio effimero. Già dal 1995 la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia cresceva di un tasso pari a un terzo rispetto alla media Ue. Ma nel 2023 siamo passati da un tasso annuale tra il +0,4% e il +0,5% a un tracollo del –2,5%, e persino in Germania che pure nel 2023 è entrata in recessione la perdita di produttività del lavoro si è limitata a -0,3%, mentre Francia e Spagna crescevano del +1,5% e del +0,8%. A tale disallineamento brutale si sommano altre tre cadute. La produttività del captale è scesa di quasi un punto percentuale, dopo una risalita negli anni post COVID fino al +1,6%. La produttività multifattoriale, che misura le componenti di utilizzo di tutti gli input compresi e processi organizzativi, gestionali, logistici e tecnologici, è scesa a sua volta del -.2.5%, dopo che nel 2022 aveva toccato il +1,7%, per effetto di sostenuti apporti sia della componente ICT che di quella di beni immateriali (proprietà intellettuale). Infine, il valore aggiunto complessivo realizzato in tutti i settori della produzione di beni e servizi di mercato è cresciuto solo dello 0,2%, dopo che nel post COVID era salito fino al +6% tra grandi esultanze perché finalmente sembrava conclusa la lunga era in cui solo la manifattura realizzava cospicuo valore aggiunto in crescita mentre i servizi no. Ed è la caduta del valore aggiunto a spiegare le perdite di produttività sia del lavoro che del capitale. Perché l’aumento di occupati e ore lavorate, sbandierato dai governi come vera prova della forza dell’economia italiana nell’ultimo triennio, è stato 13 volte superiore alla crescita del valore aggiunto nel 2023. E mentre l’intensità di capitale continuava a crescere anche nel 2023, la frenata a quasi zero dell’aumento di valore aggiunto ovviamente ne abbatteva la produttività.
I 22 mesi di contrazione della produzione industriale e una crescita del pil tornata a mezzo punto percentuale difficilmente possono indurre a credere che il 2024 segnerà un balzo rispetto ai dati 2023. Ergo bisognerebbe invertire il segno di molte politiche sin qui seguite. Primo: il lavoro. Per quanto possa sembrare impopolare, bisogna smetterla di anteporre a tutto il resto gli incentivi fiscali e contributivi che spingono le imprese a nuovi assunti, perché gli 1,3 milioni di occupati aggiuntivi del triennio sono stati assorbiti dai settori a più bassa produttività e valore aggiunto. E’ incredibile che il governo abbia persino subordinato la sua mini IRES premiale per sole 18 mila imprese a nuove assunzioni, oltre agli abbattimenti contributivi già previsti. Secondo, gli incentivi agli investimenti. La perdita di competitività dovrebbe indurre a riservare quote crescenti di sostegni pubblici soprattutto a imprese che realizzano verificabilmente sostenuti aumenti di produttività e valore aggiunto. Terzo: le dimensioni d’impresa. Bisogna investire tantissimo al fine di realizzare – dalla distribuzione commerciale alle micro e piccole imprese manifatturiere – fusioni, accorpamenti e ristrutturazioni di filiera, con poltiche attive del lavoro per accompagnarli ma efficaci, cioè affidate a privati, invece di restare ancorati agli inefficienti i Centri Pubblici per l’Impiego a cui continuiamo a destinare miliardi. E’ una rivoluzione? Sì, lo è. Ma è da babbei, fingere che la perdita di competitività sarà sopravanzata dal genio italiano.