Da Aristotele a Totò alla fisiognomica. In “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie”, Riccardo Falcinelli racconta chiamando in causa arte, politica, semiotica, neuroscienze
“Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera!”, esclama sconsolato il cavalier Torquato Pezzella (Totò) nel film di Steno “I tartassati” (1959). Proprietario di un lussuoso negozio di abbigliamento ed evasore impenitente, commenta così il volto truce dell’integerrimo maresciallo della polizia tributaria Topponi (Aldo Fabrizi) che gli annuncia una multa salata. In effetti, per secoli si è dato per scontato che non solo gli occhi fossero finestre dell’anima, ma che pure bocca, denti, capelli potessero dire qualcosa sul carattere di un individuo. E quindi che la faccia potesse essere letta e decifrata come si fa con un testo o con una mappa. In fondo, anche la “kalokagathía” greca, ossia l’unione di bellezza e bontà, partiva dall’assunto che l’aspetto fisico fosse strettamente legato a quello morale.
Di contro, il saggista francese Claude de La Bellière narra nella sua Physionomie raisonnée (1664) che, quando bisognava giustiziare i colpevoli di uno stesso reato, si cominciava sempre dal più brutto, come se i suoi difetti estetici costituissero una colpa aggiuntiva. Insomma: chi era brutto era più assassino di un assassino meno brutto. Questo modo di ragionare, noto col nome di “fisiognomica”, accompagna l’umanità dalla notte dei tempi. Perché la faccia è la parte del corpo più soggetta ad attribuzioni di senso, come racconta Riccardo Falcinelli – chiamando in causa l’arte, la politica, la semiotica, le neuroscienze, la moda, i cosmetici – in un divertente e dotto volume, Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie, (Einaudi, dicembre 2024).
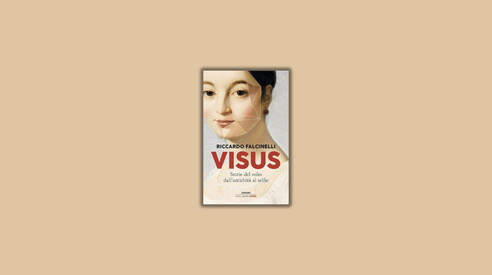
L’origine della parola “volto” è incerta. Secondo alcuni filologi, l’etimo latino di “voltus” rimanda al lato visibile degli oggetti; secondo altri ha la stessa radice di “volo” e “voluptas”, richiama cioè l’immagine del volere e del desiderio. La parola “faccia” ha invece un’origine meno complicata: deriva dal verbo “facio”, che significa fare ma anche comporre, rappresentare, fingere. Ciò vale per i pittori fiamminghi che dipingono il volto di tre quarti, come per chi ha inventato la posa frontale utilizzata nei documenti d’identità.
Per non parlare dei moderni sistemi di sorveglianza che si basano su uno studio attento dei lineamenti, a cominciare dal software di riconoscimento facciale contenuto negli smartphone. Sono tutti episodi della perenne attività creativa sul tema del volto: Bernini scolpisce la bocca un po’ aperta per dare l’idea che il soggetto stia respirando; Rembrandt riesce a mostrare con giuste pennellate lo scorrere del tempo; Marie Tussaud usa la cera per creare somiglianze perfette ancorché inquietanti; Franz Hanfstaengl a metà Ottocento mette a punto il fotoritocco, anticipando il futuro dei filtri di TikTok; Max Factor brevetta un fondotinta il cui effetto risulta quasi invisibile nelle pellicole in Technicolor. Ma non solo gli artisti e i designer, tutti noi abbiamo a che fare con la faccia degli altri. E mai come oggi il nostro volto si presenta sotto forma di immagine: nei selfie, nei reel, nelle riunioni online. E ogni mattina ci guardiamo allo specchio e ci pettiniamo, ci rasiamo o ci trucchiamo, ci sistemiamo gli occhiali o controlliamo soltanto che sia tutto in ordine. In quel momento capiamo che il nostro viso è un “medium” significante.
Secondo alcuni studiosi, le origini della fisiognomica risalgono al periodo paleo-babilonese, circa quattromila anni fa. Forse all’inizio era un’arte divinatoria, simile alla chiromanzia: nel volto era iscritto il destino delle persone. Il testo più completo sull’argomento che conosciamo, Physiognomica (probabilmente del III secolo a.C.), è stato a lungo attribuito ad Aristotele, anche se il vero autore non è mai stato identificato con certezza. Il (falso) filosofo stagirita parte da una premessa: visto che la malattia o l’ubriachezza sono evidenti sulla faccia, perché non dovrebbe accadere lo stesso con tutte le altre affezioni dell’animo? Da qui un elenco sterminato di corrispondenze tra qualità “esteriori” e qualità “interiori”: ad esempio, chi ha i capelli morbidi è pavido; chi li ha ispidi è coraggioso; chi li ha crespi è codardo. Inoltre, quel testo ricorre spesso a paragoni col mondo animale: chi ha gli occhi piccoli è meschino, come le scimmie; chi li ha grandi è lento, come i buoi; chi ha la fronte minuscola è rozzo, come i maiali.
Lo “Pseudo Aristotele”, come viene chiamato, ne conclude che la qualità intermedia è sempre la migliore. In particolare, la pelle non deve essere né troppo chiara (come quella delle donne) né troppo scura (come quella degli etiopi e degli egiziani), perché in entrambi i casi è segno di vigliaccheria.
“In facie legitur homo” è l’adagio latino che riassume la cultura fisiognomica in epoca ellenistica, dove confluiscono tradizioni diverse: esoterica, divinatoria, naturalistica e anche medica. E’ proprio quest’ultima che si rivela cruciale per la divulgazione dei suoi princìpi. Secondo la scuola di medicina inaugurata dal greco Ippocrate (460-377 a.C.) e sviluppata dal romano Galeno (129-200 circa), l’organismo è dominato da quattro sostanze fondamentali in equilibrio tra loro: il sangue (che ha sede nel cuore), il flegma (il muco che ha sede nella testa), la bile gialla (che ha sede nel fegato) e la bile nera (che ha sede nella milza). La rottura di questo equilibrio determina gli stati patologici della salute.
Così, a partire dall’Alto Medioevo, questa medicina degli “umori” si sovrappone alla fisiognomica, spesso senza soluzione di continuità. E’ infatti il gioco degli umori che definisce l’aspetto delle persone: l’eccesso di freddo le rende basse, il caldo alte, l’umido le ingrassa e il secco le prosciuga. A tale miscuglio di saperi si affianca nel Duecento l’astrologia, grazie alla riscoperta di molti testi arabi, in cui spicca il termine “firasa”, ossia la capacità di diagnosticare la personalità di chiunque fin dalla “prima impressione”. In Medio Oriente designava un mestiere molto richiesto e ben retribuito. Il fisionomo si occupava di scegliere gli schiavi, raccomandava i consiglieri al sultano, decideva quali cammelli e cavalli acquistare; e lo faceva guardandoli in faccia. In Europa, una prima sintesi del “firasa” la incontriamo nel 1230, alla corte di Federico II: è il Lyber Physiognomiae di Michele Scoto, che cerca di dare a quella disciplina uno statuto scientifico.
Una branca della fisiognomica che si afferma nel Rinascimento è la “metoposcopia”, una tecnica che prediceva il futuro attraverso l’esame di rughe e nei. La novità ha curiose ripercussioni sul costume: poiché i nei vengono reputati indizi interiori, la nobiltà sei-settecentesca contrae l’abitudine di applicarsene dei posticci per comunicare un preciso stato d’animo, consultando appunto le tabelle metoposcopiche. Questo sofisticato gioco di corte scomparirà con la Rivoluzione francese, insieme al collo dei partecipanti. Tuttavia, il trattato di fisiognomica più di successo tra i contemporanei – e anche tra i posteri – compare nel 1586: è il De humana physiognomonia di Giovan Battista Della Porta (1535-1615). Ma all’erudito di Vico Equense non importa tanto l’esegesi del viso, quanto la sua messa in scena.
Tra i suoi numerosi interessi c’è infatti il teatro, e nelle sue commedie compaiono bizzarri attori ingegnosamente camuffati come l’uomo-pecora o l’uomo-becco, che suscitano grande ilarità tra gli spettatori. Della Porta riprende in realtà il modello drammaturgico del teatro greco basato su opposizioni radicali: da una parte i protagonisti, giovani e leali, dal portamento slanciato e col naso dritto; dall’altra i vecchi, i parassiti, i servitori, di solito torvi, larghi, caricaturali, spesso con un naso grosso e adunco. Il naso pronunciato, del resto, era il segno distintivo degli ebrei deicidi raffigurati nelle stampe e nei quadri dell’epoca. Un antisemitismo “visivo” che resiste ancora nei nostri giorni.

Questa millenaria miscela di pregiudizi e stereotipi torna in auge in pieno Illuminismo, quando esplode la moda delle silhouette: minuscoli ritratti di profilo, ritagliati su carta scura, che si trasformano in un ricercatissimo intrattenimento mondano. Il nome deriva da quello del ministro delle Finanze di Luigi XV, Étienne de Silhouette, famoso per la sua parsimonia nelle spese del re. Diventa quindi sinonimo di qualsiasi opera minimale o eseguita in economia, e segno di tempi in cui raccontare se stessi è considerato chic: tutti vogliono la propria silhouette, e nei salotti non si parla d’altro.
Per il teologo svizzero Johann Kaspar Lavater (1741-1801), invece, non era un semplice gioco di società. Al contrario, per il pastore protestante dalla struttura della fronte si poteva dedurre addirittura la moralità di un individuo. Affascinato dal “magnetismo animale” di Franz Anton Mesmer e dalle magie di Cagliostro, Lavater è convinto che Gesù aveva la pelle bianca e un naso dritto come una statua greca. Con i suoi scritti si procura una vasta fama sia nei ceti popolari che tra gli intellettuali di mezza Europa, con cui intrattiene una fitta corrispondenza (anche Goethe gli manifesta la propria stima). I suoi libri vengono tradotti in ogni lingua del continente e divengono dei bestseller letti nei circoli culturali più prestigiosi.
Il “lavaterismo”, infatti, forniva alla nascente borghesia industriale, intimorita dalle imponenti migrazioni contadine verso i centri urbani, una specie di manuale contro i pericoli della modernità. C’è chi utilizza la sua fisiognomica per assumere la servitù e chi per scegliere la moglie o il marito ideali. Nel giro di un cinquantennio, il lavaterismo diventa così un patrimonio di idee largamente condiviso, grazie anche all’uso che ne fa il romanzo popolare. Eugène Sue descrive i criminali con Physiognomische Fragmente (1775-1778) sulla scrivania. Lo stesso fa Conan Doyle. Ma anche in Balzac, Stendhal, Dickens, e persino in Dostoevskij, il ritratto dei personaggi è influenzato, più o meno direttamente, dai paradigmi elaborati dal teologo zurighese.
Essi sopravviveranno anche nel cinema, nei fumetti e nei cartoni animati della prima metà del Novecento. Basti pensare alla strega disneyana di “Biancaneve e i sette nani” (1937) o a quella del film di Victor Fleming “Il mago di Oz” (1939). Più tardi, saranno proprio i cartoonist di Walt Disney a osare scelte più sofisticate. Nel film “Cenerentola” (1950), creano un contrappunto di nasi differenti, uno per ciascun personaggio. Sotto tale profilo, nei loro disegni si avverte qualche eco del romanzo ottocentesco. I “cattivi” appartengono a una precisa classe sociale: l’aristocrazia minore decaduta, le cui facce crudeli sono lo specchio del suo declino. Confrontando il volto di Cenerentola con quello delle sorellastre Anastasia e Genoveffa viene in mente una celebre battuta di Schopenhauer, che allude alla ferocia estetica che attraversa le distinzioni di classe: “Una lieve incurvatura del naso, in giù o in su, ha deciso della felicità della vita di innumerevoli ragazze”. Certo, si tratta di fiabe. Ma siamo sicuri, si chiede Falcinelli, che ancora oggi in molti non si lascino influenzare da luoghi comuni che resistono all’usura del tempo?
Per Alexander Todorov, professore di psicologia alla Princeton University, per rispondere bisogna riformulare la domanda. E la domanda giusta non è cosa comunica un determinato tipo di viso, ma in cosa consiste la cosiddetta “prima impressione” a cui si è già accennato sopra. Ebbene, ciascuno di noi, fin dalla nascita, è sottoposto a una determinata “dieta visiva”: quella di un cinese di Pechino è diversa da quella di un londinese o di un madrileno. Essa forgia un’immagine mentale di quel che è tipico e di quel che non lo è, e intralcia la comprensione di ciò che si discosta dall’aspetto del gruppo etnico, sociale o famigliare al quale si appartiene. Motivo per cui un europeo fa fatica a distinguere tra volti giapponesi e coreani; e un orientale fa fatica a distinguere un tedesco da un italiano. Ovviamente, il melting pot attenua i pregiudizi visivi, ma non li annulla completamente. Pregiudizi che persistono anche in virtù di una pubblicità televisiva e sulle riviste patinate nella quale il casting – come osserva Falcinelli – seleziona nella maggioranza dei casi gli uomini e le donne che rispondono a precisi canoni di bellezza.
Quando la maison Gucci ha scelto per le sue sfilate di moda la modella Armine Harutyunyan, sul web si è scatenato il finimondo. Migliaia di giudici del tribunale digitale hanno messo sul banco degli imputati le sue sopracciglia folte, il naso grande, la figura spigolosa. Insomma, l’hanno condannata perché non è “bella”. Eppure nel terzo decennio del terzo millennio nessuno dovrebbe credere sul serio alla fisiognomica. Tutti dovremmo stare dalla parte di Cyrano de Bergerac, lo spadaccino-poeta dal naso enorme il quale dimostra che l’aspetto fisico prediletto dalla chirurgia estetica e dal marketing non ha nulla a che vedere con le qualità morali, intellettuali e culturali di un essere umano.
